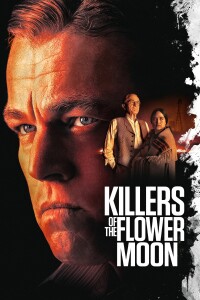THE EQUALIZER 3 – Senza tregua, recensione
Qui sganciato da vincoli editoriali, mi defenestrerò, cioè mi caccerò giù dalla finestra, no, mi fionderò e lancerò in una spericolata recensione colorita e colorata come la pelle d’ebano di Denzel Washington, uno che non abbisogna di pittarsi di “noir” il viso ma di black n’è connaturato in maniera pura, ah ah, in forma totalmente en nature, eh eh.
Ebbene, senza tregua, ovvero il suo sottotitolo, più che altro senza pietà, chissà, recensisco ivi lapidariamente tale episodio conclusivo e, sotto ogni punto di vista, mortuario. A mio avviso, sottovalutato in modo non plus ultra. Poiché noi italiani siam avvinazzati, no, lasciando stare i prosecchi, siamo avvezzi a ironizzare troppo di fronte, paradossalmente, a film hollywoodiani ambientati in terra italiota, no, italica con tanto di trattorie rustiche, viuzze antiquate e scalcinate con l’aggiunta di vinelli stagionati e prelibati d’ottima annata. Vedasi Ferrari? No, il film di Michael Mann è indubbiamente su di giri come un ubriaco fradicio, suvvia, non siamo affatto, stavolta sì, avvinazzati, nell’asserire fermamente che è alquanto insalvabile, se non fosse per la sua ultima mezz’ora finale in cui, grazie a un incidente stradale, no, testacoda micidiale a livello cinematografico, rinnalza l’epica carente per quasi tutta la sua durata impresentabile e barcollante. Mann, dopo tanti capolavori, in quel di Modena deve aver bevuto troppi Pignoletti, girando un film, peraltro, poco allegro ma molto tetro, più cupo d’una comare secca di Alberobello, cari trulli, no, miei citrulli.

Marco Quaranta (ANDREA DODERO) and his men terrorize the citizens of Altamonte in Columbia Pictures THE EQUALIZER 3. Photo by: Stefano Montesi
Orsù, mie prodi e porci, miei orsi e uomini (l)ombrosi(ani), dopo un incipit in cui l’uomo nero invincibile (Denzel Washington) Robert McCall, per l’appunto, par (non ci è dato con certezza sapere) esser entrato di soppiatto in un vigneto siciliano, trucidando chiunque ma aspettando il signorotto mafioso poiché fermato, chissà perché, dai suoi scagnozzi che poi ammazzerà assieme al sudato e suddetto lor capo dei capi (quest’ultimo, ovviamente, non Totò Riina, poi steso e massacrato ma i coglioni ai suoi servizi, il nostro Robert, non poteva “servirli” e ucciderli prima?), dopo botte da orbi e una sparatoria allucinante, assistiamo alla ripresa panoramica di un ferry–boat che sembra un piroscafo arrugginito, anzi, la nave, neanche troppo male, a dir la verità, del King Jong di Peter Jackson. Al che, il gorillone McCall sta morendo dissanguato vicino all’Isola del Teschio, no, rasato come un teschio ambulante, in quel dell’Aspromonte, no, nei cipressi del cimitero alle porte, no, nei pressi della veramente esistente, presente sulle mappe geografiche, Altomonte, in provincia di Salerno. Ove viene assistito e curato, disinfettato dalle ferite letali e quasi mortali, riabilitato dal buono e caro, bonario medico campano Enzo Decaro, ah no, Decaro è un attore, forse… dicevo, Robert è medicato da Enzo Ferrari/Adam Driver, no, da quello attempato di Le Mans ‘66 – La grande sfida, alias Remo Girone nei panni, qui però, di Enzo Arisio. Uomo che non è invecchiato bene, a livello fisico, a differenza del vino migliore, forse è, comunque sia, un brav’uomo ma segretamente bavoso e fan del culo su Instagram di Arisa e prepara buone sogliole. Macché, eh eh. Comunque sia, alla soglia di ottant’anni suonati e in sovrappeso in modo metaforicamente “obeso”, eh eh, non è del tutto in pensione ma, per l’appunto, malgrado il notevole pancione, ancora lavora e tratta Robert come se fosse il suo figliol prodigo, adorato e “piacione”. Cosicché, memore di Mario Merola, eh già, I figli… so’ pezzi ‘e core, pare non fregargliene nulla… se Robert può esser o meno un figlio di puttena della madonna e della malora, per dirla in pugliese. Lo ospita a casa sua e gli dà mangiare a ogni ora, inoltre Robert, il quale presto s’italianizza in Roberto, potrebbe essere un ladro, uno di quegli extracomunitari odiati a morte da Salvini & company senza permesso di soggiorno ma, non solo nel solaio, no, soggiorno di Enzo, bensì dappertutto nella sua abitazione e spaziosa, graziosa dimora, per innumerevoli notti e dì magna a sbafo e caga, piscia e dorme con tanto di letto a due piazze su arredamento da paesino del sud in cui gli uomini e le donne non si rinnovano mai con l’Ikea. Forse, meglio così. Il film è mancante di idee? No, le idee son sovrabbondanti come la panza prominente delle classiche donne del mezzogiorno, chiatte, di una certa età abbondante. Scusate se v’appaio ripetitivamente ridondante.
Donne le quali, è risaputo e non è un banale luogo comune, dopo aver figliato, si lasciano andare, tanto non se le scopa più neanche il marito. Dunque non hanno bisogno di abbellirsi. Sono pezzi d’antiquariato come un quadro fac-simile di Botero, oh oh.
Il marito di codeste, peraltro, è probabilmente per di più morto da tempo immemorabile, abbandonandole nei “vicoli ciechi” dell’assistenza sociale e del perpetuo, economico precariato sempre in pericolo di crollo come le loro case diroccate in zona prossima allo sfratto e abitate da molti ratti. Sono donne dai grandi valori, loro tengono duro, eccome, tanto di cappella, no, cappello indossato ivi da McCall, servito e riverito dai più costosi negozi d’abbigliamento della zona, non sono mica donnacce in cerca di sol((d)i e minchie tante come le baldracche super-ingioiellate. Costoro, di contraltare e riveliamone gli altarini da chiesa di Altomonte, son semi strafighe, giammai sfigate, perennemente griffate, molto rifatte e palestrate che impazzano sui social più in vista per rendere strabici gli uomini, facendoli… impazzire, donne non uguali, diciamo, alla Vergine del Carmine che si svendono in maniera spudoratamente puttanesca. Se lo possono permettere, non avendo neanche una ruga, figurarsi se la borsa sotto gli occhi! Si danno da fare… per una borsetta in più firmata Christian De Sica, no, Dior. Ora, comprare una bella borsetta di Dior alla propria donna non fa “uomo d’onore” ma onore e basta. Ma queste qua, spesso e volentieri “disonorate”, si fanno regalare addirittura i “gioielli” dagli uomini più, per modo di dire, felicemente sposati con l’anello, miei agnellini e donnine che fate le santarelline. Invece, donne sudiste che vi sudaste l’essere mignotte, no, la pagnotta sebbene vostro marito contadino e/ panettiere, pur essendo poverissimo, v’infornava il “p… ne” e a stento, con molti stenti, vi manteneva da vecchie galline che fa(ceva)n buon brodo, voi sì, eh eh, che foste e siete delle buonissime cristiane e che la madonna, per l’appunto, v’accumpagn’… ah, povere “criste!”. Plurale femminile di Cristo! Porco Giuda!
La vostra vita non è da Dior, dunque non dorata, ma che vi frega? A Natale, vi papperete il Pandoro! Ridendo dinanzi a un cine-panettone dei più volgari, al contempo buonisti, e continuerete a sognare questo Washington “nerone” ché, come direbbero giustappunto, in meridione, deve aver nù gross’ ciddone, cioè un ucc… one. Si sa, i neri son più dotati. Mentre vostro marito, defunto, prelevato molto tempo addietro dalle pompe funebri, sì, da Carrefour, no, dai carri e macchinone… con la carrozzeria nera, nemmeno spomp(in)aste come dio comandò e comanda. Tranne quando vi mise incinte. In quel c… o, vi furono i preliminari. Lui non vi regalò per il matrimonio neanche la dote. E voi, a costo di non essere trattate come Maddalena dalle altre pettegole paesane, perfino forse meno illibate di voi, sebbene quotidianamente bestemmia(s)te in modo inenarrabilmente blasfemo non propriamente elegante, giammai la deste e darete a un ricchione, no, riccone. Dovete tenere fede non solo alla religione giudeo-cristiana ma anche a quella nuziale, a dispetto del fa… o che il vostro consorte siede or alla destra del Padre o a(l) fianco d’un cornuto come Lucifero. Sì, Lucifero era povero ma bello, volle fottere Adamo ed Eva, quindi l’Onnipotente, stando all’Holy Bible, lo spedì all’inferno, inseminando poi, per via spaziale, non normalmente rettale, no, vag… le, la signora Maria. Nome che, fra l’altro, va forte laggiù… ah, Belzebù, salvaci tu! Chi ha orecchie per intendere, intenda, parafrasando l’uomo messo in croce che salvò il ladrone, miei bambagioni e creduloni da santi patroni.
The Equalizer 3 è un filmone? No, ma Washington è sempre lui, fa la sua porca fig(ur)a, sì, è un figone… pur essendo oramai un po’ ciccione. Chi l’ha duro, no, chi la dura la vince. E McCall scoperà la barista-cameriera mulatta di nome Aminah. Che altri non è che una napoletana vera(ce), Sonia (Ben) Ammar. Invero, Gaia Scodellaro. Cmq, parafrasando molto alla larga Totò, guarda Ammar quant’è bell’, ispira tanto sentiment’! Comunque, le preferisco la pornostar semi-chocolate Amirah Adara. Ne impazzirebbe anche il Tartufone Motta, no, Washington. Che poi è la stessa cosa, ah ah. Dicev(am)o, chi la dura la vince e Robert(o) vincerà… infatti risuona anche, all’inizio, la Turandot…
Nel trailer, ascoltiamo Domenico Modugno con la sua insopportabile e mega-inflazionata Volare (Nel blu dipinto di blu) ma nel film non la sentiamo, meglio così.
Non compare però Sophia Loren, all’anagrafe Scicolone, a urlare… Roberto!, a mo’ di quando annunciò l’Oscar a Benigni ai tempi de La vita è bella. Per McCall la vita, dopo la tragica morte della moglie, non fu invece il massimo. Ma poté e può consolarsi, sapendo che, a Napoli, molti ragazzi frequenta(ro)no scuole da Io speriamo che me la cavo, non se la caveranno, poche donne chiaveranno e non si laureeranno ma (non) finiranno come quelli di Mery per sempre & Ragazzi fuori. In questi due film non v’è naturalmente Massimo Troisi ma, a proposito di Benigni di Johnny Stecchino, no, di Non ci resta che piangere, no, di Francesco Benigno di Riso Amaro, no, dei succitati film di Dino, no, Marco Risi, il cattivo, fratello del cattivone, è incarnato dalla sua bella/brutta copia moderna, ovverosia Andrea Dodero nei panni di Marco Quaranta. Il cattivone, invece, Vincent Quaranta, è un altro Andrea, Scarduzio. V’è anche Salvatore Ruocco che incarna Salvatore, ah, che fantasia, feticcio del regista di Mary, ovverosia Abel Ferrara, autore di Pasolini e Napoli Napoli Napoli. Parafrasando Peppino de Filippo, ho detto tutto…
Uomini da Uccellacci e uccellini, uomini pasoliniani o alla principe Antonio de Curtis, cioè totoiani, per anni speraste nel Totocalcio e vi siete ridotti alla SNAI. Uomini asini, no, pizzaioli che amate Margherita la capricciosa che vuole il salame piccante, uomini da pizze in faccia, uomini presi a pizzicotti, uomini derisi, umiliati e oppressi, uomini da ‘O sole mio, siete soli e vi hanno tolto anche il reddito di cittadinanza. Il Vesuvio non erutta più ma voi di rabbia vulcanica eruttate! Ci penserà Paolo Sorrentino a regalarvi qualche gioia effimera e microscopicamente momentanea ma, in attesa della sirena dell’ambulanza, no, del suo nuovo film su La Sirena Partenope, riguardatevi È stata la mano di dio. Baciate la statuina e il santino di Diego Armando Maradona ma date retta a me! Sorrentino forse vincerà un’altra statuetta mentre voi modella(s)te e cura(s)te le vostre statuine… dell’inesistente futuro e tristissimo presente, no, del presepe/presepio da Natale in casa Cupiello. Forza, scolate la pasta Voiello, peraltro cognome del prete Silvio Orlando in The Young e The New Pope sempre di San Paolo, no, Maradona, no, Sorrentino, ed evviva il mar di e a Sorrento! Salutami a sorreta! La Voiello, coglioncelli, è una pasta cara ma non potete rinunziarvi! Annunciazione Annunciazione, Alleluja Alleluja, vostra zia Annunziata è una povera handicappata-disgraziata e la vostra racchia fidanzata, di nome Assunta, non fu mai per un lavoro decente assunta. Voi siete, come lei, disoccupati ma guardate(vi) The Equalizer 3 e god(r)ete… da matti! Sì, peraltro non vi va così male, dio maiale, De Laurentiis vi promise un altro scudetto nazional-popolare! Sarà di parola. Perciò, tutti allo stadio, forza, che aspettate… a sputtanarvi i pochi soldi che avete? GOAAAAL, si gonfia la rete!!! Ma meno il vostro portafogli! Ecco la trama, cari somari, ancora abbastanza sommaria ma sarà aggiornata, di Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Equalizer_3_-_Senza_tregua
Alla fine, giustizia sarà fatta, la folla non esulterà al grido-motto di Ho visto Maradona, eh mammà, innamorato son’, bensì a quello mutuatone di Ho visto Altomonte con le bandiere azzurre del Napoli. E vissero tutti felici e contenti, compreso McCall/Denzel. Il quale, dopo cinquemila anni (non è un’iperbole, eh eh) che non scopava per non “tradire” la moglie morta, putrefatta, sepolta e mangiata dai vermi, vi diede dentro (al)la bella guagliona nerina/etta eccitata, no, succitata. La scena di sesso fra i due di colore e gran calore, comunque, non viene mostrata ma comprendemmo il tutto… dalla dissolvenza in nero, ah ah. Ecco che, dopo Man on Fire (sì, abbiamo detto che Denzel è Nerone, lui non brucia Roma ma tutti, ah ah), Denzel ritrova Dakota Fanning. Ai tempi del film dettovi di Tony Scott, Dakota era un’innocente bambina prodigio, adesso è una gran figa che stimola al pruriginoso più “vergognoso” da malandrini. Non dobbiamo tenere nascosta la carina, no, l’ocarina, no, la verità scabrosa come la CIA. Capito la battuta d’alta scuola ficcante, miei uomini e donne peperini? La potete capire se avete visto il film. Offro io il pepe(rone)!
Di primo acchito, debbo esservi ancora onesto, Dakota mi sembrò Karen Page/Deborah Ann Woll di The Punisher. Sì, siamo lì… d’altronde The Equalizer è una specie di Frank Castle/Jon Bernthal non solo Marvel/Netflix, bensì al naturale senza tuta in latex di carbonio o nera come il carbone.
Detto ciò, Antoine Fuqua gira meglio dell’Altissimo, dovete credermi, miscredenti, la fotografia di Robert Richardson spacca il culo più di McCall e la musica consueta di Marcelo Zarvos riesce, unita al carisma potente di Denzel, a farci credere, per l’appunto, di essere in una pellicola che mischia il sacro al profano come in Scarface di De Palma (l’arredamento della casa di Quaranta è preso in prestito dalla villa di Tony Montana/Al Pacino) e soprattutto più del folclore esaltante ma terribilmente ingenuo delle feste meridionali in onore della mafia, no, della camorra/’ndrangheta, no, di vostro Signore il messia… McCall.
Che la pace sia con voi e con lo Spirito Santo.
Sia data a Denzel, no, Washington sia lodato, sempre sia lodato. Denzel girò questo film in Italia per provare pena nei suoi confronti? Non credo…
Al solito, è doppiato in modo magnifico da Francesco Pannofino. Il film fa cagare e, alla fine della sua visione, ci serve e/o servì un pannolino come quello dei bambini o dei vecchiettini? Ma no, dai, Altomonte è pittoresca come Portofino.
Perdonatemi, inoltre, se in tale review non sono stato finissimo. Se per questo volete colpevolizzarmi, domenica andrò a confessarmi, recitando al parroco l’Atto di dolore! Poi, reciterò, come da pena catechistica assegnatami, l’intero Rosario, illudendomi per un po’ di non essere l’uomo nero.
Infatti, non lo sono, sono bianco, a livello spirituale, come l’Immacolata? Non vi giurerei. Siamo tutti peccatori. E ricordate: peccatrici come la Scicolone e la Ciccone, in “arte” Madonna, hanno sempre avuto i soldoni.
Io non ho molti soldi, sono onestissimo… Tutto però mi si può dire tranne che non sia evidentemente un Genius purissimo.
Avrei preferito, però, sinceramente, ve lo dico di tutto cuore, fottermene… di più.
Mi son fatto in modo tard(iv)o, no, s’è fatto tardi. È mezzanotte e cinquantasette. Voglio dormire e domani, anzi oggi, sarà/è un altro giorno di mer(da).
Nota finale: il (suc)citato Enzo Ferrari, no, Enzo di Remo Girone, no, Enzo Decaro, appartenente in passato al trio comico formato dal compianto e sopra menzionato Massimo Troisi, assieme a Lello Arena, è nato a Portici. Mentre, in questo The Equalizer 3, assistiamo a una scena ambientata forse sotto lo stesso porticato di 5 è il numero perfetto di Igort? Film, quest’ultimo, girato a Napoli e nei suoi quartieri spagnoli, assai ovviamente fumettistico e visivamente più stilizzato di quest’opera di Fuqua?
Chissà, ah ah.

Vincent (ANDREA SCARDUZIO, right) and his man (SALVATORE RUOCCO) in Columbia Pictures THE EQUALIZER 3. Photo by: Stefano Montesi
di Stefano Falotico
THE EQUALIZER – Il vendicatore, recensione



Ebbene, dopo averlo preso in quel posto da sempre, no, dopo essermelo perso al cinema e, sino ad oggi, mai recuperato alla visione, dopo aver recentemente recensito il secondo capitolo di tal trilogia firmata da Antoine Fuqua, prima di assistere al terzo episodio ambientato in terra italica, a quanto pare quello conclusivo e forse il più brutto, ahinoi, dopo l’intermezzo personale della prima tranche del festival veneziano, eccomi qua, baccalà e quaquaraquà, a disaminarvi, libero da vincoli editoriali, il capostipite The Equalizer.
Ora, se Charles Bronson fu (ne) Il giustiziere della notte, Fuqua, memore di Taxi Driver e della puritana furia vendicatrice del “pazzo” lucido Travis Bickle, alias Robert De Niro e viceversa, oltre a centrifugare, mixare e reinventare a piacimento il succitato capolavoro scorsesiano per antonomasia, oltre a trarre spunto, naturalmente, dall’omonima serie tv alla base di questo suo opus trasformatosi, per via del commerciale successo avvenuto, per l’appunto, in un fatidico, eclatante trittico (da non confondere con un sonnifero dallo stesso nome che sarebbe servito a Bickle insonne, eh eh), afferra anche l’intuizione alla base del sottovalutato Man on Fire del compianto Tony Scott, ovverosia quella di utilizzare il suo feticcio Washington a mo’ di malinconico vendicatore (è il sottotitolo italiano, peraltro) e livellatore-risolutore che, non avendo nulla da perdere poiché già perse l’amore della sua vita, dinanzi alle ingiustizie perpetrate ai danni specialmente di giovani uomini e donne inermi e innocenti, diviene una macchina da guerra che pratica un glaciale sterminio impietoso contro chi si permise, permette e permetterà, illecitamente, di ledere vite umane altrui, danneggiandole in modo assai grave e traumatico, talvolta agendo in maniera scellerata e perfino omicida.
Stavolta, la molla che innesca la sua furia distruttrice non è ovviamente la minorenne Iris/Jodie Foster, neppure Lupita/Dakota Fanning del fuoco della vendetta, bensì la minorenne prostituta incarnata dalla carina Chloë Grace Moretz che ivi interpreta, giustappunto, un’Escort Lolita per la mafia russa di nome Alina. A proposito di Scorsese, la Moretz fu la bambina “Alice nel paese delle meraviglie” dello stupefacente e incompreso Hugo Cabret. Adesso è cresciuta ed è indubbiamente un’ottima figa. Sono passati circa dieci anni da The Equalizer e capite bene che di strada, a livello di estrogeni e sviluppo sessuale, ne ha fatta parecchia. Anche se qui interpreta una “passeggiatrice” che non rimorchia sui viali di via Stalingrado, in quel della zona Fiera a Bologna, bensì, nuovamente specifichiamo, un’intrattenitrice al soldo di papponi dell’ex Unione Sovietica le cui guardie del corpo, diciamo, prima la caricano in limousine e poi accompagnano tal accompagnatrice a trovare chi non solo la limonerà. Al che, uno dei suoi clienti l’aggredisce e le dà troppo dentro, lei reagirà e sarà scopata, no, picchiata a sangue dagli scagnozzi alle sevizie, no, al servizio del malavitoso mother–fucker. Ivan e Igor sono due nomi russi, negli anni ottanta soprattutto, usati e presi in prestito da molti genitori esterofili, filorussi italiani comunisti per chiamare i figli maschi, semmai nati a Casalecchio di Reno, e ho detto tutto. Ora che c’è la Meloni al governo, li chiamerebbero tutti Stalin, no, Benito. La Meloni, dopo il barbaro stupro oramai tristemente arcinoto accaduto in tempi non lontani, ha varato, come sappiamo, un provvedimento “disciplinare” per cui se la Moretz di Hugo Cabret dovesse marinare la scuola per andare a vedere Taxi Driver restaurato in 4K e, nel cinema ove avviene la proiezione, lei urlasse… qui De Niro era figo!, sarebbe incaprettata e spedita in una cooperativa sociale, forse a Sadurano, affinché possa essere “(ri)educata”, probabilmente psicologicamente e non solo, abusata, presa per il popò in senso lato veramente b di mano morta, da tutor calabresi laureatisi fra una mignotta ucraina e una zoccola del sud est perfino asiatico. Avete votato voi certa gente. Fra un paio d’anni, non lamentatevi quindi se un ragazzino molto intellettualmente minorato, no, mentalmente dotato, non importa se anche fra le gambe, se un duro e potenziale Martin Scorsese italiano in erba (ma sì, se fuma qualche spinello come Juliette Lewis di Cape Fear, chi se ne frega), per colpa di qualche innocua marachella da Johnny Boy di Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno, finirà come Leo DiCaprio di The Aviator e di Shutter Island.
E sarà lobotomizzato, no, psicanalizzato non da Ben Kingsley di quest’ultima pellicola dettavi, bensì da quello de La morte e la fanciulla oppure da quello di Sexy Beast. Rivogliamo i sogni alla Georges Méliès, eh eh!
Ecco, Robert McCall/Washington odia chi distrugge le speranze giovanili per istradarle al suprematismo da figli di puttana. D’altronde, sta leggendo Il vecchio e il mare. È un boomer come lo fu Ernest Hemingway o lui stesso sarebbe da internare e sottoporre a un coatto trattamento psico-farmacologico in quanto incapace d’intendere e di volere quando la sua rabbia prende il sopravvento e non riesce a controllare le sue aggressività represse che vanno presto contenute? Oggigiorno, d’altro canto, se vieni bullizzato e reagisci irosamente, sei giudicato da Paolo Crepet che definirebbe tal reazione entro i contorni dell’abominevole espressione… comportamento passivo-aggressivo di matrice fantozziana, figlio d’un disagio atavico per cui il soggetto in questione, frustrato dirimpetto agli attacchi subiti, non si comporta da Fabrizio Corona che fu. Corona il quale, comunque, a detta di Crepet, è malato di mente. Paolo invece è sanissimo. Pare che, dopo le stronzate che dice superficialmente, a casa sua, a tarda notte, si masturbi su tutte le ex di Fabrizio, optando una sera per Belén Rodríguez e l’altra su Nina Moric. Qualche volta, per non essere ripetitivo, si dà anche a Lele Mora, ah ah. Al mattino, poi legge Famiglia Cristiana fra un Bignami da psicologo della mutua e una nuova paziente “muta” da rendere ancora più problematica con la sua psicanalisi da quattro soldi che la fa(rà) sentire in colpa poiché la vuole e vorrà soltanto usare come esperimento da laboratorio delle sue elucubrazioni della min… ia al fine di ficcarla… nel suo nuovo libro del c… zo!
Robert, però, non De Niro, bensì McCall/Washington, ha ucciso dei pezzi grossi per vendicare l’abuso compiuto contro Alina. Dunque, dovrà vedersela con lo spietato Teddy Reno, no, Rensen, il cui vero nome altri non è che Nicolai Itchenko, alias Marton Csokas. Quest’ultimo un po’ somigliante a Viggo Tarasov/Michael Nyqvist di John Wick. No, più che altro il sosia fallito di Kevin Spacey. E Viggo Mortensen de La promessa dell’assassino?
Forse, a tutti questi Nic/kolai, è meglio mio zio di secondo grado, Nicola, e il fratello di mia nonna materna defunta. Che si chiama(va) Nicodemo, ah ah.
Nel secondo capitolo di questa sega di Crepet, no, di questa saga ove i cattivi terribilmente crepano, muore Susan/Melissa Leo, sposata con Brian Plummer/Bill Pullman. Dopo la morte di Susan, no, della moglie, McCall vaga fra Lost Highway lynchiane… incontrerà forse una Patricia Arquette simil Kim Novak di Vertigo oppure Bill Pullman del post-finale, mai visto, sempre di Strade perdute, acchiappato e inchiappettato dalla sceriffo di Stranger Things, alias David Harbour che qui incarna un poliziotto corrotto?
Vladimir Pushkin è invece interpretato da Putin, no, da Vladimír Kulich?
Denzel Washington è buono e caro, i finali di questo franchise sono iper-buonisti ma ricordate che se fa(re)te incazzare McCall, lui diverrà il babau, l’uomo nero. Eppur non avrà bisogno di divenire tale, già lo è come Barack Obama che stette a Denzel Washington, no, alla White House, eh eh.
Comunque, a parte gli scherzi e gli schizzi di sangue, a Paolo Mereghetti, The Equalizer fa schifo. Lo considera reazionario e compiaciuto nelle scene di violenza gratuita. Onestamente, Mereghetti, anche se dovesse subire delle ingiustizie atroci o se a subirle fossero persone a lui care, non me lo vedo nei panni di Robert McCall. Lui parla e giudica così in quanto, a differenza di McCall, secondo me, non ha mai letto L’uomo invisibile. È invece la storia della sua vita… Fotografia strepitosa di Mauro Fiore e, al di là, in effetti (speciali?), d’una certa gratuità immotivata della violenza ivi sin troppo esplicitata, The Equalizer spacca. Fuqua è un signor regista e gira con una classe e un senso del ritmo eccezionali. Per esempio, il confronto al ristorante, faccia a faccia, tra McCall & Rensen, è da pelle d’oca e Washington recita da dio. Il resto, che vi piaccia o meno, è storia del Cinema.

Teddy (MARTON CSOKAS, left) meets McCall (DENZEL WASHINGTON) at his apartment in Columbia Pictures’ THE EQUALIZER.

di Stefano Falotico
OPPENHEIMER, recensione


Ebbene (intestazione tipicamente mia, assolutamente dunque personale, di certo opinabile ma voglio sempre apostrofarvi, no, approcciarmi a voi, lettori, in tono confidenziale), come volevasi dimostrare, lo spettatore medio s’è subito precipitato in sala per assistere, condizionato dal potente battage pubblicitario inneggiante a Nolan oramai da tempo immemorabile, giustappunto, per assistere all’ultimo opus del regista di Inception. Quest’ultimo film, peraltro, fra i più sopravvalutati delle ultime due decadi così come, parimenti, la filmografia nolaniana quasi in toto. Che puzza, a mio avviso, sempre indissolubilmente di artificialità, no, d’artefatta grandeur non poco tronfia e insopportabilmente retorica. Nolan, al solito, ivi non si smentisce, riproponendoci senz’alcun guizzo d’originalità i suoi stilemi “arty” da cineasta montato, da me invece smontato e non per far il bastian contrario. Semplicemente perché non mi va a genio mentre la massa informe, naturalmente uniforme e piatta, lo consideri quasi unanimemente un intoccabile, totemico genius in forma indiscutibile. Suvvia, non scherziamo, è un furbissimo e poco simpatico cialtrone, un imbonitore del gusto medio e conformistico fra i più commerciali che maschera la sua pochezza e la sua pressoché totale assenza di poetica e cinematografico sguardo autentico, veramente passionale, dietro un’immensa coltre, per l’appunto, a base di studiata e fredda calcolazione e dietro una facciata da artista filosof(ic)o dei poveri. Malgrado sempre più s’arricchisca in maniera esponenzialmente atomica, sfruttando la dabbenaggine del suo popolo di tonti aficionados da lui manovrati e perennemente buggerati a cui fa credere di essere il Kubrick odierno. Ma per carità, poveracci(o)! Oppenheimer, infatti, altri non è che il biopic di sé stesso magnificato, trasfigurato e personalizzato, tramite un cervellotico processo d’identificazione psicologico, adattando(si), in forma solipsistica e romanzata, la “storia del realmente esistito, raccontato però a modo suo, Robert Oppenheimer, obviously. In poche parole, specialmente spicciole, per spicciarmi più che altro e per farvi capire sinteticamente in modo conciso e preciso la questione riguardante tale volpone inenarrabile, costui, pur narrandoci le zone oscure dell’inventore dell’atomic bomb, celebrandolo, comunque sia, come un assoluto genio coi suoi tanti difetti, altresì con i propri immani pregi sto(r)ici, s’immedesima nell’Oppenheimer da sé stesso sceneggiato. E ho detto tutto. Sì, perché Nolan vuole essere visto come un genio tanto ombroso, ermeticamente indecifrabile, quanto enormemente affascinante e dal carisma ipnotico, oso dire apoteotico, alla pari del Falotico, no, degli occhi magnetici, invero vuoti, e scuri d’un Cillian Murphy inespressivo come pochi. Al che, Nolan lo pedina, gli si attacca con la macchina da presa e lo riprende (da) vicinissimo, propinando noi, pedissequamente, primi piani giganteschi e ossessivi à la Sergio Leone ante litteram in ambito pseudo-scientifico su inquadrature desertiche in senso tout–court. Dietro Murphy non v’è la Monument Valley di C’era una volta il West malgrado gli orizzonti grandangolari del Grand Canyon a sfondo romantico della love story fra Oppenheimer e sua moglie, e a dispetto del fatto incontrovertibile che le iridi di Murphy assomiglino a quelle di Charles Bronson/Armonica, bensì assistiamo, desertificati, appunto, solamente allo sconfinato ed arido panorama desolante del suo Cinema mortifero e più algido dell’inesistente sex appeal di Emily Blunt. La quale è, sì, bellissima, ma non riesce mai a risultare davvero sensuale e arrapante in quanto la sua bellezza, non di plastica ma poco comunicativa, da attrice imbambolata e perfettina, non sprigiona alcuna carica eroticamente maliziosa ed evocativa. Stessa cosa dicasi per Nolan, il suo Cinema è formalmente perfetto come La Gioconda ma non appassiona come Julianne Moore. Quest’ultima non propriamente impeccabile nei suoi lineamenti del viso, una beltà, diciamo, non canonica, altresì sesquipedalmente più invogliante all’esplosione ormonale e spermatica d’una scissione nucleare. Ah, che fissato che sono, che fissione, no, con Julianne desidero un’esplosiva er… ne e anche tutta la fusone. Ma non facciamo confusione! Poiché le sue muscolose e al contempo longilinee gambe stupende, la sua carnagione più pallida del volto ceruleo di Murphy, le sue superbe lentiggini esagerate, appaiate alla sua rossissima pigmentazione pilifera e alla sua capigliatura fulva, le sue vellutate braccia morbide, intonate in modo asimmetricamente armonico al suo viso da troia alla Boogie Nights, in me scatenano solamente una reazione deflagrante. Osé, anche oso dire tendente al molto piccante, voglio esserle ficcante!
E, se un uomo non vuole scoparsela (allora è omosessuale o eunuco), no, se non vuole presto scoppiare, deve non guardarla oppure frizionarsi del ghiaccio sulle palle. Ora, procediamo con la recensione scoppiettante. Scusate, mentre scrissi le righe soprastanti, pensando intensamente a Julianne, ebbi una furente, incontenibile ed istantanea erezione, ivi scrivo tal parola appieno, e dovetti asciugarmi le mutande bagnatemi che le strapperei senza starvi a pen(s)are troppo in modo pedante, ah, che top(p)a e quella mia cosa fra le mie gambe, più rossa di lei, mi esplose in infinitesimali istanti, eh già, pochi c… zi, ragazze, no, ragazzi, debbo metterglielo quanto prima dentro, no, debbo ammettervi francamente, furono brevissimi ma densissimi mo(vi)menti tanto veloci quanto infinitamente godibili ed estasianti. Dolcemente calienti! Ah, le sfilerei i collant e le sarei colante. Ora facciamocela, no, facciamola finita con le cazzate, anche porcate, facciamo i seri e recensiamo questa pellicola che altri non è che una porcata, no, una ridicolaggine presa troppo sul serio da chi di Cinema capisce poco e, in forma direttamente, anzi, inversamente proporzionale alle sue sessuali proporzioni, no, coerente con la sua scarsa conoscenza in materia della settima arte più da atti impuri, no, pura, colto da eia… one, no, esaltazione figlia della sua ignoranza madornale, addirittura può arrivare a pensare che la Blunt sia più bella e brava della Moore. Sono serissimo, non sto scherzando, sebbene dapprima, come appena dettovi poc’anzi, qualcosa fu eiaculante, osé, no, oserei dire schizzante. (C)azz! Mi par giunto il momento di recensire il film. Che, come ampiamente detto all’inizio di tal mio pazzo, no, di questo pezzo, sta spopolando e sta entusiasmando chiunque. Tranne me. Che, anziché, no, anzi, ché, dopo averlo visto, son rimasto scioccato, praticamente sconvolto dalla sua mediocrità assoluta più disarmante. Chiarisco subito, a scanso di equivoci, Oppenheimer non è affatto brutto. È, assieme al lontano, nelle stelle, no, nel tempo oramai remoto dei primi anni duemila, Insomnia, quest’ultimo reputato dai fan di Nolan un remake scialbo e il opus suo peggiore, figurarsi che “fanatici” esperti, il miglior film di Cristo di dio, no, di Christopher. E ho detto tutto. Figuratevi gli altri, eh eh. Sto iperbolizzando, senza dubbio, altresì riconoscendo una teoria della relatività, no, una verità poco relativistica. Avevamo già avuto, qualche anno l’Orsa Maggiore, no, ora ho sonno, no, or sono, il film Oppenheimer per la regia di Nolan, ovverosia Interstellar. Soltanto che adesso Nolan l’ha girato con Murphy, cioè lui stesso in vesti attoriali, al posto di Matthew McConaughey. Per comprendere tale mia freddura, da appurare se in effetti lo sia, bisognerebbe viaggiare nel tempo e, alla velocità della luce, no, del suono, no, all’unisono, capire quando partì l’assurdo fanatismo per Nolan, paragonabile solamente a quello da molti di voi, eh già, nutrito per Paul Thomas Anderson, ovvero un altro venditore di cagate spaziali. Torniamo nel futuro, no, torniamo al film che… oltre a proporci dei cammei ingiustificati, come quelli inutili di Kenneth Branagh e Matthew Modine, di Rami Malek & company, quasi delle comparsate, e degli attori redivivi che sono più bravini di quando furono vagamente sulla cresta dell’onda o sulla rampa di lancio d’un successo mai veramente avvenuto (mi riferisco a Josh Hartnett, sì, bravi, comunque Josh è stato bravo, eh eh), questa biografia su Oppenheimer, in realtà su Nolan stesso da lui diretto, co-finanziato come sempre e scritto, (auto-ri)tratto dal libro Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato a cura di Kai Bird e Martin J. Sherwin, con dialoghi da pelle d’oca per la loro bruttezza imbarazzante (Nolan è una pessima penna), scevri cioè di qualsivoglia guizzo d’originalità e nella prima ora più stereotipati e impresentabili di quelli di A Beautiful Mind con una fiera delle banalità pseudo-scientifiche da impietrirmi più della mono espressività d’un Murphy paralizzato sol in due pose, una con gli occhi strabuzzati e una à la Benito Mussolini ebreo che sconfisse sul tempo Adolf Hitler che, a sua volta, per via del suo mostruoso e arcinoto antisemitismo contro Albert Einstein, no, Karl Marx, no, Sigmund Freud, no, Werner Karl Heisenberg, si lasciò fregare, Oppenheimer ci presenta un Robert Downey Jr. che, quasi sicuramente, vincerà l’Oscar come miglior attore non protagonista ma se l’aggiudicherà perché è dimagrito spaventosamente, divenendo scheletrico come Murphy stesso, e in quanto è stato truccato da vecchio quasi decrepito. È “mostruoso!”.
Già ci appar(v)e vecchio, aggiungo io, a inizio film quando Oppenheimer/Murphy era giovanissimo mentre quest’ultimo, puntualizzo in modo necessario, rimane abbastanza giovane, a eccezion fatta dei capelli leggerissimamente brizzolati, anche alla fine con l’aggiunta del pelato, quasi come nell’incipit che parte dal pre-finale. Downey Jr. è un grande attore, questo non si discute ma meritava la statuetta molto tempo prima per parti più belle, maggiormente sentite e, a conti fatti, perfino meglio e con più cuore interpretate. Qui è lezioso, recita, sfoderando moine a tutt’andare.
Ho letto e sentito che Oppenheimer sarebbe analogo a JFK di Oliver Stone. Ah ah, macché. Che c’entra un caso complottistico di natura filmica, lungo quasi uguale ma lineare e non discontinuo nei suoi rimbalzi delle pallottole sulla testa di John Fitzgerald Kennedy, no, non altalenante nei suoi coerenti saltelli temporali non astrusi, con una macchinosa, squinternata, sempliciotta e convenzionale storia assai tediosa che, dopo innumerevoli flashback che provocano più indigestione dei funghi atomici, no, dei funghetti porcini ammuffiti, nuovamente ci ammorba e stomaca con un’interminabile, verbosissima parte processuale da latte alle ginocchia? Fra l’altro, Jason Clarke recita permanentemente da seduto ma è meno imbalsamato della regia fermissima e piatta di Christopher. Se Downey Jr. vincerà un po’ immeritatamente l’Oscar come best supporting actor, sarebbe parimenti, no, immensamente davvero insopportabile, questo sì, eh eh, ancor più stomachevole, che Murphy trionfasse nella categoria di Miglior Attore ai prossimi Academy Awards. Murphy mi sta simpatico, tutto sommato, ma, sottolineo di nuovo, ivi recita da monolito di 2001: Odissea nello spazio con un look da patito del Biafra che, nei primi venti minuti del film, sembra George McFly/Crispin Glover di Ritorno al futuro, quindi subito dopo il ragazzo timido, “scienziato pazzo” di Peggy Sue si è sposata che voleva scoparsi, per l’appunto, insomma, darvi dentro con Peggy, alias Kathleen Turner. Con l’unica, devastante differenza che Murphy, malgrado la sua timidezza, anzi, atimia da imbranato alla Falotico, no, catatonico e, a prima vista, interessato solo agli atomi, ai neutroni, agli isotropi e non alle patate delle bombe sexy, dette altresì grandi tope, riesce, col solo potere delle sue iridi glauche azzurre sul verde smeraldo, a trombarsi bellamente Florence Pugh, la quale qui è più bona dell’ex pornoattrice Jodi Taylor, a lei assai somigliante, e nientepopodimeno che Emily Blunt. Che, come dettovi, non è Julianne Moore ma è più bella di Florence Pugh e ho ridetto tutto ancora una volta. Sì, Murphy/Oppenheimer pare John Nash schizofrenico del succitato, sopravvalutato A Beautiful Mind, non ha il fisico di Russell Crowe dell’epoca che trombava Jennifer Connelly ma, solo dopo 45 min., da studioso di Fisica e meccanica quantistica, scopiamo, no, scopriamo essersi trasformato in un fottuto adoratore della figa, un lucky bastard impenitente, un donnaiolo incallito e un “maiale” comunista che vuol far il culo ai nazisti. Per di più, prima è al liceo, due minuti dopo è laureato e dottore, tre scene successive è a capo del Progetto Manhattan. Calcoliamo che, nel brevissimo lasso temporale, ribadisco, ha avuto anche il tempo di scopare Florence Pugh e di sposare Emily Blunt. Un real genius!
I migliori della compagine attoriale sono James Remar, Gary Oldman as Harry S. Truman, il regista-attore Tony Goldwyn e basta. Peccato che si vedano solo, rispettivamente, per una manciata di minuti. Velo pietoso invece per Benny Safdie. Il quale, a proposito di PTA (acronimo di Paul Thomas Anderson coniato dagli andersoniani e nolaniani), dopo averci disgustato in Licorice Pizza, ivi recita da scemo più scemo del suo handicappato del film In Good Time girato in veste cineastica assieme al fratello.
A proposito, ripeto quest’espressione, infine, di fratelli famosi… Chi sostiene che il qui presente, inesistente, Casey Affleck sia più bravo di Ben Affleck è uno che non scoperà mai Jennifer Lopez. Ben Affleck, eterno amico di Matt Damon. È Damon che tira su il film e lo salva grazie a un paio di scene pregiate da great actor navigato e carismatico. Sì, Damon è carismatico. Chi dice, da una vita, che è insignificante è lo stesso topo, no, tipo d’uomo che preferisce Casey a Ben e Christopher Nolan ad Einstein. Nolan, per non rendere caricaturale e macchiettistico Einstein, lo fa interpretare a Tom Conti. Che assomiglia a un agricoltore della Basilicata che non ha mai non solo sfogliato un libro di Fisica, bensì ha a stento la quinta elementare. Ecco, caro Nolan, torna a scuola, non solo di Cinema.
di Stefano Falotico
Il commissario Falò 2 – Una macabra indagine personale, un libro noir di natura cinematografica

Ebbene, in attesa prossimamente di assistere al Marlowe di Neil Jordan (Intervista col vampiro) con Liam Neeson (La preda perfetta), sceneggiato dal writer di The Departed, ovverosia William Mohanan (Fuori controllo), vogliamo sinteticamente, altresì esaustivamente, presentarvi un libro di matrice analoga e speculare, perfino speculativo in merito al concetto d’investigazione nel senso tout–court della letterale sua accezione, inoltre assai inerente, giustappunto, le torbide atmosfere noir e l’urban crime più puri. L’autore di quest’articolo è la stessa persona autrice di tale opus letterario, sottostante descrittovi nella sinossi fedelmente riportatavi e trascrittavi testualmente, e ivi recensore di molte pellicole cinematografiche di valore. Trattasi non d’autoreferenziale celebrazione futile o ambiziosa magnificazione irrisoria, bensì d’una sincera esposizione anticonvenzionale di un’opera di narrativa gialla che il sottoscritto reputerebbe delittuoso non pubblicizzarvi con piena, emotiva partecipazione e sentito, irrefrenabile desiderio d’illustrarvela con ardore. Eccone la sinossi nella sua quarta di copertina enunciatavi:

Un uomo indagatore tra i più fini e supremi, un commissario scrutatore all’interno degli infernali anfratti, apparentemente insondabili, dell’incubo umano incarnato da una società buia e cupamente celante molti neri scheletri nell’armadio. Il quale, passeggiando cogitabondo nei suoi dedali neuronali, inabissandosi mentalmente fra i decumani spettrali d’una propria esistenza vivisezionante esistenzialmente i meandri d’un mondo afflitto in modo pestilenziale e forse irreversibile da una tetraggine tanto incurabile quanto esiziale, ne perlustra le oceaniche e glaciali criminosità terrificanti, amleticamente e infinitamente proteso intimamente a indagarvi in maniera coscienziosamente vera e senziente, primordialmente e visceralmente ostinato e implacabile, impietoso nella sua più profonda e misterica detection scevra da ogni compromesso e incorruttibilmente severa da investigatore à la Philip Marlowe modernamente ricreatosi e rincarnato dalla sua stilografica penna analoga allo stile raffinato e impeccabile di Raymond Chandler. Un Hercule Poirot alla Agatha Christie di natura e matrice ante litteram, un Benoit Blanc che, a differenza dei glauchi occhi bleu di Daniel Craig, possiede cangevoli e languide iridi scure allineate al suo noir vivente in mezzo al perpetuo hard–boiled metaforico di questa nostra vita ripiena di duri enigmi ostici similmente e apparentemente irrisolvibili come in un fascinoso, romantico eppur al contempo gelido giallo d’antan. Il commissario Falò, un uomo che non rinunzia alla sua altezza morale in un mondo che di nobiliare ed eticamente pregevole non ha più niente, smarritosi come fu, infatti, da tempo oramai immemorabile, in una lancinante perdizione pressoché indelebile e mortificante in modo universalmente abominevole e terribile. Su quale caso sta or indagando? Forse sul sensuale senso della vita che assomiglia a una dark lady magnetica e sfuggente, inafferrabile ed eccitante…
Tale libro è la continuazione del suo capostipite e, da quel che sopra leggeste, ne avrete immediatamente compresa la sua natura cinefila ampiamente citazionistica. Ne Il commissario Falò 2 – Una macabra indagine personale, infatti, soventemente si fa esplicito riferimento alla settima arte, specialmente quella, per l’appunto, investigativa e nera. In questa novella, dall’intreccio volutamente delirante e contorto, peraltro, vengono menzionate pellicole e lor presenti personaggi che, se non propriamente ascrivibili a qualcosa di marcatamente giallo, hanno perennemente un’attinenza profonda con la misteriosa ricerca della verità più profonda e, a prima vista, poco nitida.
Che sia, per esempio la verità concernente un caso o una situazione da risolvere lucidamente per svelarne l’arcano e scoperchiare nere ed enigmatiche realtà celate e/o agghiaccianti, riemerse in tutto il lor abbacinante nitore glaciale, oppure la verità nuda e cruda, umanissima, prettamente riguardante il disvelamento di denudatesi anime esse stesse, metaforicamente, dapprima non facilmente decriptabili in totale chiarezza cristallina…
Cosicché, ne Il commissario Falò 2, fa capolino addirittura Nicolas Cage di Next e di tanti altri film più o meno cupi mentre l’amalgama del suo narrativo andamento assomiglia non poco al citatovi Strade perdute di David Lynch.
In questa pindarica giostra immaginifica, in tale tourbillon e lessicale epifania incontenibile, infine, a un certo punto, si va a parare persino su I guerrieri della notte e John Wick 4.
Ovviamente, vivamente consigliato e disponibile sulle maggiori catene librarie online nei formati cartaceo e digitale, presto su Audible, personalmente recitato.
THE EQUALIZER 2 – Senza perdono, recensione (in attesa del terzo, mentre il primo?)

Ebbene, amici e fratelli della congrega, vale a dire la mia, quella cinefila, cari cinofili e uomini lupeschi, non solo amanti dei cani e cari miei esseri cagneschi in cerca d’affetto come cagnolini ma affetti dalla malattia del Lombroso, orsù, men (non) ombrosi, ivi sganciato da oscure paure e ubbie da medioevalistica Gubbio che fu, no, scevro da oscurantistiche ed editoriali, quasi dittatoriali regole SEO e via dicendo, vi parlerò senza filtri, in modo assolutamente personale e assai chiaro, d’un film con un nero per antonomasia, ovverosia mr. Denzel Washington. Marcantonio versatile sul fronte recitativo, molto colorito in senso tout–court, interprete di fame, cioè sempre affamato di celluloide, no, di fama mondiale che, da una vita, rappresenta e incarna, peraltro è or molto in carne e non solo è rilucente, splendido splendente come il Sole più ardente, di “abbronzata” carnagione ne(g)ra, il simbolo dell’emancipazione da ogni apartheid razzistico dei più ignobili ed esecrandi. Denzel, nobiluomo non più residente ad Harlem, che di cognome fa Washington, non è ovviamente e visibilmente un bianco, non ha fatto il presidente nella Casa Bianca (White House) a Washington, per l’appunto, ma è l’attore che personifica, di simbiosi molto metafisica, no, di osmosi psichica, no, di somiglianza fisica, no, in forma metaforica, l’eterno Barack Obama del suo popolo da Malcolm X d’ogni Spike Lee che si rispetti, che venga rispettato e strenuamente, come nel suo Barriere, combatte/a per i suoi diritti, in passato e tristemente a tutt’oggi calpestati, à la He Got Game. Per un mondo libero da ogni schiavitù castrante ove, così come avviene da molti anni a questa parte, un nero alla Jesus (questo è il nome del personaggio di suo figlio nel film appena succitato) possa diventare il nuovo Michael Jordan e scopare, alla maniera di Isiah Maxwell, perfino Jill Kelly & Chasey Lain all’unisono, infilando tutte le palle da pallacanestro, no, appartenenti alla maschile zona erogena ribollente in modo spermatico di testosteroni calienti, cioè, in poche parole prosaiche, i testicoli tosti e a livello ormonale funzionanti da omone di colore, soprattutto in calore, in tutti i buchi delle più arrapanti ed eccitanti b(i)on(d)e. Ora, non voglio sovreccitarmi, bensì di questo film parlarvi in modo pacato, no, accalorato, quasi (da) drogato, a mo’ di Denzel Washington che, nella pellicola Verdetto finale, ebbe e filmò una scena a coiti, no, a conti fatti, praticamente a luci rosse con un puttanone della madonna. Molto con lei gli crebbe ma dovette poi fare veramente il duro per dimostrare di essere più innocente di Santa Maria Goretti. Washington, specializzatosi da ani, no, come dettovi, già tanti anni fa, in fottuti ruoli da macho cazzuto che tutti prende a cazzotti. Spaccando tutt’ cos(ce). Un attore che si fa il culo… però, soltanto di sua moglie con cui felicemente sta e tromba da una vita. Fottendosene… delle altre. Ah, che cazzata micidiale ma al contempo esilarante! Washington che, dopo American Gangster, reciterà di nuovo per Ridley Scott ne Il gladiatore 2. Nella parte di Nerone? Ah ah. Chissà… rincontrando Pedro Pascal, forse scontrandosene. Pedro che qui è Dave York. Saltando a piè pari il capostipite di tale franchise, ovvero il seguente, The Equalizer, disamineremo il secondo capitolo, sottotitolato Senza perdono. Specifichiamo inoltre, utilizz(and)o or il plurale maiestatico, che prima della regia di Antoine Fuqua, si pensò a Russell Crowe, suo antagonista nel sopra menzionatovi film di Scott, per il ruolo assegnato a Washington, alias Robert McCall. Anche il regista, prima che subentrasse Fuqua, amico di Washington dai tempi di Training Day, fu il director di Blade Runner & Alien? Mah, informatevene e, semmai, recatevi su Wikipedia, anche per leggerne la trama, stavolta del 2, ih ih: https://it.wikipedia.org/wiki/The_Equalizer_2_-_Senza_perdono
Per dovere di cronaca, non nera come la pelle di Denzel, bensì solamente giornalistica, la prossima settimana, precisamente l’imminente e vicinissimo 30 agosto, uscirà da noi The Equalizer 3 – Senza tregua, ma non perdiamoci in dettagli alla Fuqua, no, (f)utili. Secondo invece IMDb, ecco la trama di questa seconda adventure ripiena, al solito, di scazzottate potenti e infinite sparatorie interminabili con tanto di spappolate budella e dita mozzate: Robert McCall serve una giustizia risoluta per gli sfruttati e gli oppressi, ma quanto lontano andrà quando si tratta di qualcuno che ama?

Beh, una sinossi veramente stringata e più spicciola dei modi di McCall/Washington. Uno che, se lo fai incazzare, non va tanto per il sottile, come si suol dire… lui te le suona, infatti, ed è più vendicativo, sanamente e giustamente cattivo di Creasy in Man on Fire – Il fuoco della vendetta. Quest’ultimo film fu diretto, come sappiamo, dal compianto Tony Scott, ex frequente regista “preferito” di Denzel, fu dalla Critica amato in maniera controversa, parimenti a questa sega, no, saga. Da molti, difatti, aspramente stroncata e accusata, senza mezzi termini, di essere troppo violenta in forma gratuita e sovente ingiustificata, da altri, per l’esattezza la restante metà, invece, di contraltare e in maniera diametralmente opposta, assai amata e di lodi incensata. Sul sito aggregatore di medie recensorie, metacritic.com, riscontra attualmente un discreto, sebbene di certo non ottimo, tantomeno lusinghiero, 50% di opinioni favorevoli. A dimostrazione estremamente riassuntiva del nostro assunto poc’anzi esplicatovi. McCall, come nella serie televisiva originaria, è un Charles Bronson ante litteram, un redivivo Giustiziere della notte più scuro in viso di Denzel stesso? Ah ah, no, caratterialmente brusco e irascibile, indomito e guerrigliero, rabbioso a morte e punitore infallibile in un mondo ricolmo di stronzi e andato puttanescamente, no, parlandovi figurativamente, a mignotte. Denzel fotte… i figli di troia, non è un lucky bastard come un “rinomato” porn actor col muscolo perennemente (s)tirato, bensì è lui stesso un mother–fucker della min… ia, c… zo! È elegante, comunque, quando lavora, veste in tiro. Ecco, adesso passiamo alla trama, sì, sono ripetitivo? No, falotico e quindi dico la mia: Robert McCall, naturalmente ex agente della DIA (da non confondere con la CIA e non fate gli “agenti segreti” dei poveri che cercano il pelo nell’uovo), reinventatosi come tassista notturno, financo diurno, a Roxbury, in quel di Boston, non hai mai dimenticato la morte della moglie e, per elaborare il lutto, stranamente fa il Batman di turno. Dopo una sua revenge di missione in Turchia, ove salvò la vita della figlia della sua libraia di fiducia, a fargli visita è la sua unica amica rimastagli, Susan Plummer (Melissa Leo). Che gli consiglia di darsi pace. Susan è sposata con lo scrittore Brian Plummer (Bill Pullman), da cui ha preso il cognome. Spoiler: Susan viene assassinata. Facile immaginare quel che succederà… la sua furia vendicatrice, senza requie e sosta vietata, no, alcuna, si scatenerà. Poiché McCall è memore di Travis Bickle/De Niro di Taxi Driver? O perché Fuqua & company saccheggiano e scopiazzano mezza storia del Cinema, mixando il tutto in un pot–pourri di riciclato, pasticciato, sanguinolento déjà vu? A sua volta da non scambiare col titolo di uno dei film dell’accoppiata Scott/Washington? Tony, non Ridley, eh eh. In Alien, il personaggio di Sigourney Weaver si chiama(va) Ripley. Fotografato benissimo da Oliver Wood (Face/Off), morto a febbraio di quest’anno, sceneggiato alla buona e in modo grossolano, datane la trama per l’appunto risibile, dal quasi “ignoto” Richard Wenk, recitato grandiosamente da Denzel, il film regge quasi esclusivamente su di lui e sul suo immarcescibile carisma indiscutibile da nero, no, da puro uomo vero e duro! L’intreccio, banalissimo, è costituito da continui pretesti per giustificare il perpetuo reiterare di violenze senza fine (è vietato ai minori di 16 anni) intervallate a “sketch” buonisti ove l’accanito vendicatore solitario, altresì lettore sfegatato, nostro beniamino e antieroe McCall, tanto acculturato quanto “sofisticato” nelle compiaciute sue brutte maniere, manesche a dir poco, per pulirsi la coscienza, elargisce consigli paternalistici al prossimo suo, specialmente a Miles Whittaker (con due t) che non è interpretato da Forest Whitaker, bensì dal giovane Ashton Sanders. Il quale par ivi il ragazzo bisognoso di qualcuno che lo indirizzi sulla buona strada a mo’ del neretto di Smoke redentosi da un’esistenza da sbandato per merito del character di Whitaker stesso. Il quale, dopo avervi litigato e dopo averlo severamente sgridato, lo coccolò da pupillo, assegnandogli vari lavoretti da schiavetto. Il film, dunque, nel suo sviluppo narrativo inesistente è insulso come Pascal, attore che a me non dice francamente nulla. Ma Denzel spinge… sul pedale dell’acceleratore… delle macchine a tutto spiano, gigioneggiando da par suo senza freno a mano, no, inibitorio freno, sparando da ebefrenico, no, freneticamente, uccidendo senza sprezzo del pericolo, ed è sempre l’orgoglio nero fattosi persona perfino citato e glorificato da John Turturro di The Night Of. Turturro, amico di Denzel, che in He Got Game non fu Jesus ma, ne il Grande Lebowski, eccome, sì, un omonimo che però tradì il detto nomen omen. Infatti, nel film dei fratelli Coen fu un pervertito pedofilo poco cristologico. Dio santo!
di Stefano Falotico
MILLENNIUM – Uomini che odiano le donne, recensione

Ebbene, ivi sganciato da vincoli editoriali limitanti, cari fratelli della congrega appartenenti agli uomini disossati da tale vita spolpante le nostre pie anime prodigantesi per la beltà totale in un mondo sempre più carnale, sessualmente aberrante da catalogo Instagram di Postalmarket e annessa esposizione fiera, vanagloriosa di fiere da Manzotin, ovvero di uomini e donne prosciutti, no, prostituitisi al mercimonio globale, svilendosi alla strega, no, alla stregua di prodotti commerciali da mercerie, no, macellerie online, in attesa febbricitante di assistere al nuovo opus di David Fincher, cioè The Killer, recensirò il film del titolo di questa recensione, coming soon, ovverosia prossimamente, disaminato, forse vivisezionato in modo sia goliardico che poetico. Inoltre, cari smemorati e poco di dio timorati, sebbene io sia convinto ateo irredimibile oramai in modo irreversibile, posso però intellettualmente asserire, forse soltanto pontificare moralisticamente con tanto di sovrabbondante retorica a tamburo battente, che vidi lo svedese The Girl with the Dragon Tattoo nel 2009, sì, or mi riferisco all’adattamento del primo capitolo letterario ad opera del compianto (da chi?) Stieg Larsson per registica mano di Niels Arden Oplev con Noomi Rapace, scusate, dicevo, perdonate se sono massimalista come il parimenti deceduto, forse più geniale, David Foster Wallace, riprend(iam)o il discorso… quando la mia coetanea Noomi Rapace, invero leggerissimamente più giovane di me di qualche mese, non suscitava in me alcun turbamento poiché fui considerato asociale, sì, poco socievole, anzi, “socialmente pericoloso” come Lisbeth Salander, eh eh, in quanto poco consono a una società di “adulti” che canta Sara di Pino Daniele a tutto volume nella notte di San Silvestro ma è affetta da una malinconia, no, mascolinità più tossica di un liceale italiano che, ad Amsterdam, durante le vacanze, natalizie e/o estive, pratica turismo sessuale, tifando per la migliore Coca-Cola à la Vasco Rossi e per la più cazzuta “eroina”, e all’unisono “sniffa”, forse snobba, probabilmente, perfino ubriaco fradicio, intona barcollante La mia signorina di Neffa. Dicevo, (non) mi sono fatto… una alla Rapace… pur confessandovi che adoro le donne tatuate come Karma (Palmer) Rx & Katrina Jade, al contempo disdegnando i finti, non molto fini, machi che reputano Natalie Portman di Léon una bambina ma se la farebbero… nelle mutande dinanzi ad Anne Parillaud di Nikita, sparandosi poi il cosiddetto trip, sì, viaggio nella capitale suddetta dell’Olanda eppur non conoscendo Autopsia di un sogno. Ah ah. Ora, se andate da un uomo medio italiano e gli chiedete qual è invece la capitale della Svezia, vi risponderà Helsinki che è della Finlandia, quindi non giustamente Stoccolma. Comunque, esiste sempre l’eccezione che conferma la regola. Se agli uomini medi come me piacciono i tatuaggi sui corpi femminili, a Vittorio Sgarbi piace da morire la Venere di Botticelli ma, tanti anni fa, Elenoire Casalegno lo lasciò perché Vittorio la offese, dandole, come sua consuetissima abitudine, la patente di “troia” dopo che lei si tatuò una caviglia. Vittorio, veramente un esteta della venustà, anche del suo coglione sto(r)ico, forse solo quello di Destra? Vittorio, un uomo che celebra i grandi pittori dei santi e sa castrarsi al fine di non usare, per molto tempo, il suo “pennello”. Lo stesso Sgarbi che, a Porta a Porta, insultò Gabriel Garko, definendolo una bellezza per gay prim’ancora che Garko facesse coming out sebbene Eva Grimaldi e Manuela Arcuri non avessero mai sospettato sui gusti sessuali dell’interprete d’un celeberrimo film di Tinto Brass. Ma che c’entra?



Dicevo… che mi crediate o meno, andai a vedere la pellicola eccitante (mica tanto) con Garko, no, quella dapprima succitata con la Rapace assieme a dei felsinei tizi eterosessuali che sognavano di girare un porno alla Marc Dorcel, malgrado, per dirla in bolognese, non funzionasse molto il lor ucc… ll’ perché assumevano droghe? No, drugs. È la stessa cosa? No, intendo gli psicofarmaci… In tal caso, gli psichiatri ebbero ragione a reputarli pazzi. Erano e sono dei casi umani senza speranza. Nel caso, invece, del sottoscritto, molte persone credettero che io fossi misogino, sì, che odiassi il gentil sesso, così che costoro, dei malfattori, vollero troppo ingentilirmi. Ah ah, avete capito la freddura? Sì, credo che questi qua, in vita loro, siano stati fortunati, a differenza dei poveri, appena dettivi, poveri cristi sfortunati… Se avessero incontrato uno psichiatra, anche della mutua, sarebbero stati ritenuti matti? No, solamente Bruno di Sacha Baron Cohen, eh eh.
Ora, facciamo i seri. Perché prima non lo fumo, no, fummo, se volessi usare il plurale maiestatico? Dunque, non fate i furbi, come si suol dire, della “min… hia”.
Ecco, il film svedese sopra citato non mi piacque molto e non vidi gli altri due. Fino a ieri, invece, non avevo visto per intero questo film di Fincher. Il quale, ai tempi della sua uscita, dichiarò che la sua trilogia sarebbe stata, non solo migliore di quella svedese, bensì fra le più belle della storia del Cinema. A tutt’oggi, non c’è nessuna trilogia, come ben sap(r)ete, neppure il sequel. Fincher fu tra gli inventori della serie tv Netflix, anch’essa interrottasi, Mindhunter, ça va sans dire. Che, se per esigenze logistiche e di sintesi dovessi(mo) riassumervela in pochissime righe, potrei e potremmo delinearla da profiler, no, entro questa seguente e assai concisa sinossi esigua: l’FBI, per catturare i maniaci a piede libero, studia le menti dei maniaci in carcere e/o ospedali psichiatrici.
Aggiungo io, spiritosamente, altresì comprendendo che Fincher stesso ha una mente più contorta di quella di Charles Manson.
A parte gli scherzi e le esagerazioni, in Italia tradussero il libro e i capostipiti di tale trilogia, però non fincheriana, eh eh, con tale (sotto)titolo… Uomini che odiano le donne. Ovviamente. In quanto, mi scoccia ripetermi, l’italiano medio, in effetti, odia le donne ma passa la maggior parte del tempo libero a desiderare perfino quelle degli altri. Se a uno di questi gli si dice la verità, vale a dire che è un puttaniere, no, soltanto un guardone, lui ti dà del maniaco, urlandoti “vi(ri)lmente” in faccia che lui è un credente della Sacra Bibbia. Anche del Nono Comandamento? Ah ah. È lo stesso che asserisce, orgogliosamente, di adorare i film sui maniaci perché lo eccitano a dismisura e stimolano mentalmente ma, forse, pensa che Zodiac sia un film di merda perché alla fine il cattivo non viene inculato e fottuto.
Morale della fav(ol)a: in effetti, c’è molta coerenza negli italiani, non c’è che dire. Se, nel Belpaese, per modo di dire, ti piace qualche canzone di Elton John, se va fatta bene, non ti prendi del “frocio” ma sicuramente la patente di femminuccia. Se invece sei disposto a pagare 500 Euro per andare a vedere, insieme alla tua compagna molto fedele, Chris Martin dei Coldplay perché la tua ragazza si bagna mentre lui, cioè Cristo, no, Chris, canta, sei un uomo vero e che della vita hai capito tutto. Potresti anche aver capito molto, suvvia, soprattutto che sputtanasti 1000 Euro, essendo andato, per l’appunto, al concerto con la tua topa, no, tipa. In particolar modo, dopo il concerto, lei, ancora sovreccitata, financo impasticcata, ti sbranò a letto e tu ne venisti piacevolmente divorato. Il mattino seguente, però, capisti che lei scopò, col pensiero, Chris Martin.
Ma ora devi portare i figli a scuola e non hai tempo per entrare in paranoia a mo’ di Tom Cruise di Eyes Wide Shut. Anche perché, dopo averli accompagnati, al lavoro, fra una pausa e l’altra, guardi su Instagram le ex di Chris Martin. Sei “in vena”, cosicché compri i “prodotti” di Gwyneth Paltrow da regalare a tua moglie per alimentare la serata hot. Infatti, i figli sono, questa sera, dalla nonna. La quale, stanchissima, si addormenta e non li porta a letto. Alla tv, ripassa Halloween di Carpenter. I figli crescono troppo in fretta come la Salander. A una certa età, i genitori li porteranno dal dr. Loomis, no, da qualche psicologo perché non credono ai “valori”, sono stati scoperti a fumare erba e, anziché ascoltare Elton John, no, solo canzoni d’amore buoniste delle più dolciastre, mettono su la musica dei Nine Inch Nails. Adesso, Trent Reznor, però, non è figo ma è “sol” il compositore preferito di Fincher, e la vostra la figlia femmina gli preferisce il contemporaneo Damiano David, mentre quello vostro maschio va matto per Victoria De Angelis. Tutto ok, fin qui. Il problema è che, il frontman e la chitarrista dei Måneskin piacciono rispettivamente pur a questi genitori, sì, alla madre e al padre di tali figli che non amano più la buona musica di una volta, il vero rock alla Led Zeppelin e il metal tosto alla Bauhaus e Joy Division, c… o! Allora, tutti insieme appassionatamente, si sparano… un altro concerto dei Coldplay. Semmai, al padre piacciono, adesso, Whitney Houston e Aretha Franklin. All’epoca, per non sfigurare coi suoi amichetti razzisti, sosteneva che gli facevano schifo. Ma sia lui che i suoi amici sbrodolavano per Alicia Keys.
Secondo la telegrafica trama riportataci da IMDb: Il giornalista Mikael Blomkvist è assistito dalla giovane hacker Lisbeth Salander nella sua ricerca di una donna che è scomparsa da quarant’anni.
Vietato ai minori di quattordici anni per via di alcune scene violente e scabrose, adattato ed è un televisivo sceneggiato, no, sceneggiato per la trasposizione cinematografica dal grande Steven Zaillian (The Irishman, regista di The Night Of, etc. etc.), assai stereotipato però in molti punti nella caratterizzazione dei personaggi, specialmente secondari (vedasi, per esempio, Nils Bjurman, alias il tutor(e) assistente sociale marpione e porcone incarnato dall’attore Yorick van Wageningen, peraltro molto in carne), nella prima mezz’ora assomiglia a Cena con delitto – Knives Out, ah ah. Pardon, naturalmente il film appena menzionatovi di Rian Johnson è venuto dopo. Johnson, autore anche dello script, fu candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Originale? Praticamente copiata e mutuata da Fincher/Zaillian. Poiché Benoit Blanc/Daniel Craig e Harlan Trombley/Christopher Plummer sono ricalcati sulla falsa riga di Mikael Blomkvist ed Henrik Vanger. Inoltre, ad essere sinceri di mente investigativa e meta-cinematografica, dopo lo “scandalo” Kevin Spacey, Ridley Scott, per Tutti i soldi del mondo, chiamò Plummer forse dopo aver visto Millennium. Con le importanti e dovute differenze, infatti, Vanger e J. Paul Getty sono molto simili…
Rooney Mara/Salander scopre che Blomkvist pratica il cunnilinguo ad Erika Berger/Robin Wright e poi viene costretta dall’eccitato, no, succitato Bjurman ad effettuargli una fellatio.
La fotografia di Jeff Cronenweth è magnifica e impeccabile, il film, onestamente, meno. È un buon film ma non eccezionale, forse troppo lungo. Infatti, a mio avviso, due ore e trentotto minuti è un minutaggio eccessivo per un thriller così costruito, sebbene quello svedese durasse pressappoco uguale.
Lo svedese ha inoltre una media recensoria, su metacritic.com, un pelino, come si suol dire, superiore ma non troppo. E, nel suo essere più autentico, meno artefatto ed elegante, è forse addirittura migliore di questo di Fincher. Tale film di Fincher ottenne, va però sinceramente ammesso, ottime critiche ma inferiori, per l’appunto, al film con la Rapace. E, sebbene la Mara sia brava, la Rapace funzionava di più.
È per questo che Fincher decise di lasciar perdere con gli altri due, originariamente concepiti, seguiti? Mi seguite?
Nel cast, Julian Sands. Come sappiamo, trovato morto recentissimamente dopo essere scomparso a lungo. Qui è sconvolto per colpa della tragedia avvenuta.
Invece, nella parte di Martin Vanger, Stellan Skarsgård. Per finire, Joely Richardson è Harriet o Anita Vanger? Eh eh. Secondo me è bona.
In conclusione: moralistico e terribile nella scena del tatuaggio I am a rapist pig.



di Stefano Falotico
ZODIAC, recensione
Ebbene, ancora libero ivi da costrittivi vincoli editoriali, in attesa di assistere al nuovo opus di David Fincher, ovverosia The Killer, che debutterà in laguna, al Festival di Venezia a venire, compiendo veloce promemoria, conti celeri alla mano, credo di aver visto tutte le opere di Fincher. Compresa la sua creazione Mindhunter, serie tv di sopraffino stile, ahinoi, interrottasi, pare in forma definitiva alla seconda stagione, in cui rifulse la beltà magnetica della stupenda Anna Torv. Serie ideata dal regista di Fight Club, quest’ultimo, probabilmente, il suo film più controverso e probabilmente il “peggiore” assieme a Panic Room, diretta da lui stesso in alcuni episodi chiave. Fincher, il quale ancora spacca la Critica per The Game, un regista ostracizzato, no, molto amato, oscarizzato per il suo film all’apparenza meno fincheriano, vale a dire The Social Network, uno con la testa “matta” che adora le storie pazzesche soventemente, per l’appunto, incentrate su torbide e contorte, dedaliche indagini in forma di detection nerissima e spettrale, inerenti la ricerca e relativa scoperta di uomini lombrosiani o soltanto ombrosi, acquattati al buio, lupi solitari che par languiscano nel silenzio mortifero e, all’improvviso, estraggono dal cilindro, semmai, un romanzo pindarico, financo esoterico, bislacco, sia ironico e goliardico che citazionistico, autistico, no, artistico e figlio d’un uomo lucido, altresì allucinato, forse solamente à la Falotico più pregiato, eh eh: https://www.ibs.it/commissario-falo-vol-2-libro-stefano-falotico/e/9791221487848

 Io son uno che non effettua promozione occulta? Può darsi oppure evidentemente, stando ai fatti probatori, in senso metaforico, del link sopra immessovi, nulla occulta pur dandosi, talvolta, al nullismo e al feroce, cinico, probabilmente sol romantico nichilismo più sanamente cristallino. Ecco, a vedervi chiaro, non terminai mai la visione di Millennium – Uomini che odiano le donne. Ma provvederò quanto prima. Chissà mai, inoltre, se Fincher completerà tal trilogia finita appena iniziata, giammai finita, e dunque non tale. Ma torniamo a noi, ritorniamo in noi, non smarriamoci nella fosca notte dei miei deliri recensori e pubblicitari, eh eh. Potrei essere, in fondo, lo Stieg Larsson italiano e, un domani, qualche regista, forse me stesso, trasporrà in saga per il grande schermo il “franchise” letterario del commissario Falò. Infatti, dopo i primi due capitoli, attualmente per l’appunto disponibili alla vendita sulle maggiori catene librarie online, prossimamente, non tradendo il detto non c’è due senza tre, vi sarà un’altra avventura imperdibile di proporzioni titaniche, ciclopiche o tragicomiche. Se la trasposizione dovesse accadere, la protagonista non sarà Noomi Rapace, neppure Rooney Mara. Al massimo, le due appena menzionate ex signorinelle adesso signore a tutti gli effetti e inevitabile, reciproco invecchiamento, potranno apparire in ruoli secondari se accetteranno di prenderne parte, eh eh. In quanto, il commissario verte su qualcosa di molto autoreferenziale, probabilmente neanche troppo. Michael Fassbender, dopo il flop immenso ma immeritato di Snowman, tratto dall’omonima novella di Jo Nesbø, oltre a essere in The Killer, se il sottoscritto non se la sentisse d’incarnare sé stesso, potrebbe rimpiazzarmi. Se trovassi i soldi, lo pagherei a peso d’oro e, nella clausola contrattuale concernente il suo accordo, con tanto di firma in calce, apporrò un “bonus” riguardante me, ovvero il seguente:
Io son uno che non effettua promozione occulta? Può darsi oppure evidentemente, stando ai fatti probatori, in senso metaforico, del link sopra immessovi, nulla occulta pur dandosi, talvolta, al nullismo e al feroce, cinico, probabilmente sol romantico nichilismo più sanamente cristallino. Ecco, a vedervi chiaro, non terminai mai la visione di Millennium – Uomini che odiano le donne. Ma provvederò quanto prima. Chissà mai, inoltre, se Fincher completerà tal trilogia finita appena iniziata, giammai finita, e dunque non tale. Ma torniamo a noi, ritorniamo in noi, non smarriamoci nella fosca notte dei miei deliri recensori e pubblicitari, eh eh. Potrei essere, in fondo, lo Stieg Larsson italiano e, un domani, qualche regista, forse me stesso, trasporrà in saga per il grande schermo il “franchise” letterario del commissario Falò. Infatti, dopo i primi due capitoli, attualmente per l’appunto disponibili alla vendita sulle maggiori catene librarie online, prossimamente, non tradendo il detto non c’è due senza tre, vi sarà un’altra avventura imperdibile di proporzioni titaniche, ciclopiche o tragicomiche. Se la trasposizione dovesse accadere, la protagonista non sarà Noomi Rapace, neppure Rooney Mara. Al massimo, le due appena menzionate ex signorinelle adesso signore a tutti gli effetti e inevitabile, reciproco invecchiamento, potranno apparire in ruoli secondari se accetteranno di prenderne parte, eh eh. In quanto, il commissario verte su qualcosa di molto autoreferenziale, probabilmente neanche troppo. Michael Fassbender, dopo il flop immenso ma immeritato di Snowman, tratto dall’omonima novella di Jo Nesbø, oltre a essere in The Killer, se il sottoscritto non se la sentisse d’incarnare sé stesso, potrebbe rimpiazzarmi. Se trovassi i soldi, lo pagherei a peso d’oro e, nella clausola contrattuale concernente il suo accordo, con tanto di firma in calce, apporrò un “bonus” riguardante me, ovvero il seguente:
«Lì (data ovviamente da stabilire), il sig. Fassbender s’impegna con tale atto firmato a interpretare il film Il commissario Falò per la cifra milionaria pattuita. Se il film dovesse superare i 100 milioni di dollari d’incasso a livello globale, Fassbender promette di consegnare sua moglie, alias Alicia Vikander, al signor Falotico per una notte di sesso selvaggio. Di contraltare, il Falotico, non essendo un maniaco come Zodiac, qui dichiara fedelmente a Fassbender che tratterà benissimo la sua compagna anche se non può giurargli che, dopo la notte avuta con lui, Alicia non voglia chiedere a Fassbender il divorzio. Il sig. Fassbender, dunque, spera naturalmente che il film vada bene ma non troppo, altrimenti, se non volesse divorziare, Alicia potrebbe “confiscargli” la casa a Beverly Hills, intestata peraltro a lei, quindi sostanzialmente sol prenderlo a pedate affinché lui ne smammi, casa per di più in cui Michael e lei convivono or felicemente, e intestarla al suo nuovo compagno.
Se il sig. Fassbender dovesse tradire gli accordi ivi presi e tale serio impegno, pagherà la penale e non vi sarà motivo oltremodo d’indagare a mo’ dei “commissari” giornalistici di Zodiac. Infatti, in caso di defecazione, no, defezione, al sig. Fassbender penderà il potente gravame d’un durissimo capo d’imputazione».

A parte gli scherzi, credo che Fassbender e la Vikander (non) stiano assieme, no, non so se hanno una casa in quel di Los Angeles ma, a distanza di molti anni da quando lo vidi per la prima volta in dvd su una specie di tablet, cioè quando fui “internato” in “manicomio”, poche ore fa, ora ho sonno, no, poche or or sono (piaciuto il gioco di parole?) rividi la pellicola in questione e presa in esame.
Zodiac è del 2007, io del ‘79 e tale omicida seriale dello Zodiaco non si sa bene, a tutt’oggi, quando nacque. Se fosse, così come quasi certamente fu, Arthur Leigh Allen (incarnato da John Carroll Lynch), l’anno di nascita lo sapremmo? Controllate su Wikipedia, anche in merito alla fin troppo particolareggiata però, tutto sommato, “indiziaria” trama inseritavi. Poiché, per chi non lo sapesse, con l’immediato mio spoiler, immantinente saprete che lo Zodiac(o) non fu mai catturato. Sebbene forse fu individuato e perfettamente identificato, atrocemente sospettato, giammai incriminato, processato, arrestato e alla pena capitale condannato. In California, informatevene, c’è la pena di morte? Tutto inizia infatti, macabramente, a Vallejo, durante la triste serata agghiacciante del 4 luglio del 1969, nel dì notturno della festa del giorno dell’Indipendenza quando una giovanissima coppietta (lei è spostata, no, sposata, ma tradisce il marito con un “bimbo”, è pedofila?) decide di non sostare a un drive–in ma, per sbaciucchiarsi, limonare, eroicamente ed eroticamente, sinceramente trombare fottutamente, si apparta in una zona lontana, per modo di dire, da sguardi indiscreti di possibili guardoni frustrati. Viene vilmente e tragicamente aggredita da un uomo che noi spettatori non vediamo in viso. Lo stesso uomo che, sempre in California, nell’apparentemente tranquillo pomeriggio del 27 settembre dello stesso anno suddetto, in quel del placido lago Berryessa, nella contea di Napa, assalta mostruosamente altri due ragazzi isolatisi per amoreggiare in santa pace e per viversi serenamente una giornata di baci e coccole spensierati. Lo stesso uomo, per di più, che comincia a recapitare al San Francisco Chronicle delle missive preoccupanti, allarmando il giornale, chiunque e scotendo l’opinione pubblica. Ad occuparsi di lui, nel tentativo di stanarlo pian piano, l’eccellente e scafato, sebbene ubriaco debosciato, Paul Avery (Robert Downey Jr.) che, nel frattempo, stringe amicizia col “ritardato” (così viene testualmente, poco simpaticamente appellato) vignettista e puro Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal). Presto, interverrà, in merito alle indagini sullo Zodiaco, anche il risoluto, chissà se poi arrendevole, investigatore della Squadra Omicidi di nome Dave Toschi (Mark Ruffalo). In un intrecciarsi spasmodico e inquietante di colpi di scena a raffica, di battute taglienti e investigazioni al cardiopalma, in un crescendo rossiniano e palpitante d’emozioni instillateci e distillate da un Fincher assai ispirato, elegantissimo e capace di forgiare un impressionante ritmo mozzafiato a un film di due ore e mezza nel quale, dopo la prima mezz’ora, non assistiamo paradossalmente a nessun altro spargimento di sangue (fra l’altro, le scene di violenza iniziali son già sparute, volutamente edulcorate e trattenute, quasi stilizzate e ben asciugate), Zodiac arriva alla fine e avvince grandiosamente. Zodiac è un capolavoro e non si discute. Rimane dentro a distanza di parecchio tempo dalla sua visione ultimata, strazia le viscere e colpisce duro. Eccezionale fotografia di Harris Savides che, dopo The Game, rincontra qui Fincher per poi non incontrarlo più, chissà perché.
Il cast fa più paura dello Zodiaco. In quanto, oltre ai tre pezzi da novanta succitati e a un Brian Cox mellifluo e incisivo malgrado i pochi minuti in scena, sfilano Elias Koteas, Philip Baker Hall, Anthony Edwards, Dermot Mulroney, Jimmi Simpson alla fine prima che diventasse famoso, Charles Fleischer e una magnifica, dolcissima Chloë Sevigny.

Fincher va a nozze coi profiler che sempre vi prendono ma non sempre lo stronzo acciuffano. Vedasi, il succitato Mindhunter. In Zodiac, nei panni del realmente esistito Melvin Belli, v’è il sopra dettovi Brian Cox, alias Hannibal Lecter di Manhunter. Il ruolo, inizialmente, fu però proposto a Gary Oldman. Che prima firmò e poi lasciò. Chissà, forse intimorito da qualche clausola pericolosa a mo’ di quella sopra da me scrittavi. Ah ah.
Se The Killer sarà presentato, in Concorso ufficiale, all’80.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Zodiac concorse per la Palma d’oro al 60º Festival di Cannes.
Specificato ciò, fu accolto molto favorevolmente dall’intellighenzia critica planetaria e ne concordo appieno, così come già suggeritovi. In quanto, ribadisco, è il miglior film di Fincher in assoluto, parimenti il più ostico e meno spettacolare. Ed è basato su un soggetto di Robert Graysmith (il personaggio di Gyllenhaal), autore di molti libri sullo Zodiaco, sceneggiato da James Vanderbilt e, mi par ovvio, filmato e adattato dal regista de L’amore bugiardo – Gone Girl.
Nota di merito, per concludere, da dedicare proprio a Gyllenhaal. Che, nel 2007, sembrava ancora un po’ “stordito” come in Donnie Darko per cui nessuno avrebbe onestamente immaginato che, a prescindere da Jarhead, venuto prima di Zodiac, sarebbe diventato un palestrato sempre più bravo, peraltro, a livello prettamente attoriale.
All’epoca, infatti, assomigliava addirittura a Tobey Maguire di Wonder Boys, a proposito di Robert Downey Jr…
Tobey Maguire di Wonder Boys era quasi uguale a me. Che, nel 2017, invece assomigliò al Gyllenhall di Stronger. Poiché, dopo essere stato denunciato, anni prima, da imbecilli che non volevano uno scrittore, bensì un maschione da caserma militare alla The Covenant, finii quasi disabile e in terapia riabilitativa per essere omologato alla comune massa di tonti. Oggi come oggi, rimango buono di cuore come Gyllenhaal di The Covenant e fedelissimo al modus operandi dello Zodiaco, no, della scrittura creativa del Michael Douglas di Wonder Boys. Michael Douglas è stato strepitoso ne Il metodo Kominsky e, detta fra noi, a Charles Bukowski e al suo alter ego Henry Chinaski, preferisco (il) Basic Instinct. Se apro le gambe come Sharon Stone, la gente capisce che non sono una donna, neppure un trans e, verso i coglioni che mi bramano eppur contro di me tramano, adotto lo stesso stile dello Zodiaco, no, di Catherine Tramell. Cioè, lascio che vogliano fottermi come il detective Nick Curran/Douglas per poi ribaltare la posizione e metterli sotto.
Buonanotte.


di Stefano Falotico
AMERICAN GANGSTER, recensione


Ebbene, nuovamente ivi dissociato da vincoli editoriali, libero, creativamente, di scrivere remoto da ammorbanti regole SEO, libero di redigere il tutto, diciamo, in modo non canonico, scriverò una recensione alla Falotico (invero, già scritta, sotto immessa, eh eh), riguardante questo bel film, però non eccezionale, firmato da Ridley Scott nel 2007. Da me già visto, credo, se non ricordo male, l’anno dopo. Oppure nel 2009? A voi certamente non importa questo trascurabilissimo dettaglio mio temporale-mnemonico, quasi da smemorato o (im)perfettamente memore dei miei trascorsi cinefili. Questi, sì, non affatto dimenticati. Spero invece che possa interessarvi la mia disamina peculiare e, ribadisco, fermamente sottolineo immantinente, tal review finalmente non propriamente classica, pedante e noiosa. Con qualche inevitabile svolazzo pindarico.
Orsù, American Gangster, film della durata interminabile di 170 minuti abbondanti, nella sua versione rimontata ed estesa, forse solo netti, miei inetti, film sopravvalutato, soprattutto da Paolo Mereghetti che, all’epoca, gli assegnò 3 stellette e mezza sicuramente esagerate e figlie d’un entusiasmo non ponderato ma circostanziato alla sua visione affrettata e troppo magnificante l’opus di Scott? Il film presenta nel cast, oltre ai due attori protagonisti, tre ottime figliuole che poi enunceremo singolarmente, lodandone le beltà sensuali. Donne peccaminose? No, scatenanti voglie libidinose. I due interpreti principali sono Denzel Washington & Russell Crowe, che marcantoni, entrambi premi Oscar e due maschi alfa, tutti e due or ovviamente invecchiati e perfino ingrassati, irrecuperabilmente il secondo, aggiungo e preciso, io. I quali, anni or sono, furono rispettivamente rappresentanti della virilità fatta persona e sex symbol(s) in carne e ossa, no, incarnanti la mascolinità razzisticamente agli antipodi. No, non ho scritto una cosa razzista. Appartengono infatti e oggettivamente a due palle, no, allo stesso sesso ma hanno pelli diverse, cromaticamente parlando a riguardo del loro colore epidermico. Washington, attualmente, sta girando Il gladiatore 2 (nella parte di Nerone?, ah ah) mentre, che ve lo specifico a fare, Russell ottenne l’Academy Award come Best Actor per Gladiator, prima sua collaborazione con Scott. Per Washington, American Gangster, dopo tanti film girati col fratello compianto di Ridley, ovverosia Tony Scott, fu la prima sua esperienza col regista di Alien. Mentre per Crowe fu la terzultima sua collaborazione col director’s cut, no, director e basta, di Blade Runner che, come sapete, presenta varie versioni. Quasi tutte approntate da Scott stesso? No, solo una è stata approvata dal regista di molti film che doveva invece cancellare dal primo all’ultimo minuto, in quanto inutili e filmati, come si suol dire, con la mano sinistra. A cui andrebbero inclusi Nessuna verità e Robin Hood, le ultime due pellicole, per l’appunto, della coppia Scott-Crowe? Sceneggiato egregiamente da Steven Zaillian (regista di The Night Of, writer di The Irishman e Schindler’s List), malgrado qualche dialogo didascalico e scontato, diretto con buon piglio da uno Scott inedito (poche volte, infatti, si cimentò con un gangster movie vero e proprio, tralasciando le incursioni in ambienti malfamati, vedasi, per esempio, Black Rain), American Gangster è prolisso, spesso troppo manicheo, ripieno di superflue digressioni messe un po’ a casaccio per allungare il brodo, con un impresentabile Cuba Gooding Jr. nei panni del realmente esistito Leroy Barnes e un assurdo cammeo inspiegabile assolutamente da parte di Norman Reedus in quelli del detective di nome (ma guarda un po’ che fantasia ad assoldare lui) Norman, e un Washington che cita e mostra una foto di Martin Luther King per ricordarci Malcolm X, gigioneggia a tutto spiano oltre il legalmente cinematografico accettabile, rendendosi sovente insopportabile e antipatico alla pari del character da lui interpretato, alias Frank Lucas. Inizialmente, all’apparenza, un normale “manovale” della criminalità più bieca del New Jersey. Autista inseparabile del suo boss Bumpy Johnson che gli muore, nell’incipit, tetro e suggestivo, quasi fra le braccia, malgrado la chiamata tardiva dell’ambulanza. Paragonabile a Scarface di De Palma, probabilmente ricalcatone nel canovaccio, il film segue l’ascesa al potere da narcotrafficante del Lucas/Washington suddetto. Contrastato dal coriaceo poliziotto Richie Roberts (un Russell Crowe sorprendentemente con la sordina ma, con una pettinatura perfettina che poco si confà al suo fisico taurino da picchiatore indomabile e già, d’innata costituzione fisica, poco tendente al magrino).
Lucas, in men che non si dica, in virtù d’un coraggioso intrallazzo con un mammasantissima del Triangolo d’oro thailandese, importando da quest’ultimo eroina purissima, diviene un temuto uomo di potere glaciale.
Un iceman che si vendicherà brutalmente anche dello stronzo mr. Tango (Idris Elba) e sposerà una giovane fanciulla prelibata, bella ma forse illibata e molto ambita, Eva (Lymari Nadal).
Di mezzo c’è financo l’ambiguo ma fascinoso, forse facilmente corruttibile, investigatore Trupo (Josh Brolin). Richie, intanto, durante le sue indagini, oltre a lottare contro Lucas, tentando di acciuffarlo, più che altro inchiodarlo, deve combattere in tribunale con l’ex moglie Laurie (Carla Gugino) perché lei vuole proibirgli di vedere suo figlio. Nel frattempo, Richie, in apprensione eppur al contempo sbattendosene legalmente, no, leggermente, si sbatte tranquillamente la sua fottuta avvocatessa del c… zo (KaDee Strickland, la quale assomiglia alla pornostar Pristine Edge).
Ecco, ho appena eccitato, no, succitato le tre sexy women che dapprima citai. Nessuna di esse però mostra nudamente le sue grazie. Solamente l’ultima eccitata, no, da me poc’anzi citata, cioè la Strickland, esibisce a malapena le sue gambe mentre Richie/Crowe “le dà dentro” e se l’ingroppa bellamente. Che ottima monta(ta), no, che supremo e sincronizzato montaggio di Pietro Scalia.
La fotografia, eccellente e chiaroscurale, atmosfericamente plumbea e demodé, di Harris Savides, è di certo la cosa migliore d’un film piacevole, sebbene dispersivo e affetto da una tediosa lungaggine non necessaria. Sì, American Gangster è, evidenzio ancora, un buon film, altresì nulla di che. Allineato, abbastanza banalmente, ai triti e ritriti stilemi consunti della classicità hollywoodiana più prevedibile e frequentemente monocorde. Con molte scene telefonate, stupidamente violente in forma gratuita e ingiustificata. Con un Washington, come di consueto, sì, bravo eppur spesso e volentieri sopra le righe fastidiosamente, rimarco. Che forse faceva le prove generali per Equalizer. E che, da Man on Fire in poi, specialmente, pare divertirsi un mondo (noi, onestamente meno, lo preferiamo nel suo Barriere) a indossare il ruolo del duro e del figo cazzuto figlio o di troia o machiavellico contro i figli di puttana più bastardi e irredenti.
L’ex di Mara Venier, il villain di Sylvester Stallone in Dredd – La legge sono io, sua brutta copia senza muscoli, (in)dimenticabile in Gotti, incarna un personaggio à la Lorenzo il Magnifico dei poveri e dei narcos. Brolin, inoltre, prima di Sicario di Denis Villeneuve e del sequel del nostro Stefano Sollima, Soldado, imita il Benicio Del Toro di quasi tutta la filmografia di quest’ultimo. In quanto, il grande Benicio è oramai tristemente chiamato quasi esclusivamente, da Traffic in poi, a essere o uno che combatte i cartelli di droga, messicani e non, oppure il dottor Gonzo drogato di Paura e delirio a Las Vegas, arrivando quindi a essere il re degli spacciatori come in Escobar di Andrea Di Stefano. Ridley Scott, a ottanta primavere, ancora ce la fa a scopar’ Gian(n)ina Facio? A volte, forse pensa, fra sé e sé… non più gliela faccio. Allora mi faccio, no, giro un altro film e bevo una cioccolata calda della Ciobar. Il suo Napoleon sarà forse più brutto del lifting della Facio? Impossibile. E Il gladiatore 2? Francamente, con tutta la stima possibile per Paul Mescal e Washington, un gladiatore senza Russell Crowe e Joaquin Phoenix, sarà come Harrison Ford in Blade Runner 2049. Guardabile ma anche no. Ora, scusatemi, non amo la mescalina e non conosco benissimo tale Mescal. Vado a fumare una sigaretta Philip Morris Blu e lascio stare la droga di Lucas/Washington, qui denominata Magic Blue. Amai di più il fu Magic Johnson e, detta fra noi, a Denzel Washington, preferisco il Tartufone Motta. Alle donne, Denzel, invece, piace molto. Avrà un ucc… ne? Non è dato saperlo. Nel film, Ricochet, non glielo vediamo fra le cosc’ ma ha una scena di sesso interrazziale, dopo essere stato narcotizzato, con una bionda whore a mo’ di Isiah Maxwell. Quest’ultimo ce l’avrà anche lungo ma, quando scopa, pare che non goda molto, sarà per colpa del fallo, no, fatto che, per girare “tremila” (iperbolizzo) film per adulti al mese, con ogni probabilità, assume(rà) sostanze stupefacenti che lo fanno venire, inoltre, poco. Ma che c’entra ciò con il resto?
Alle “donne” di Maxwell, soventemente, non c’entra…
Ah, dimenticavo, perdonate per lo “spogliarello”, no, lo spoiler seguentemente dettovi: Richie/Crowe, alla fine, incula Lucas/Washington. Sì, Russell lo fotte. Allo stesso modo, parzialmente lo salva e il culo gli para. Quindi, non è razzismo, le cos(c)e andarono così.
Per finire, He Got Game di Spike Lee fa alquanto schifo. Malgrado Jill Kelly & Chasey Lain si esibirono in una quasi R Rated scene… con un neretto, vezzeggiativo di Nerone. Ah ah. Infatti, costui interpretò il pargoletto di Denzel.
E ho detto tutto…




di Stefano Falotico