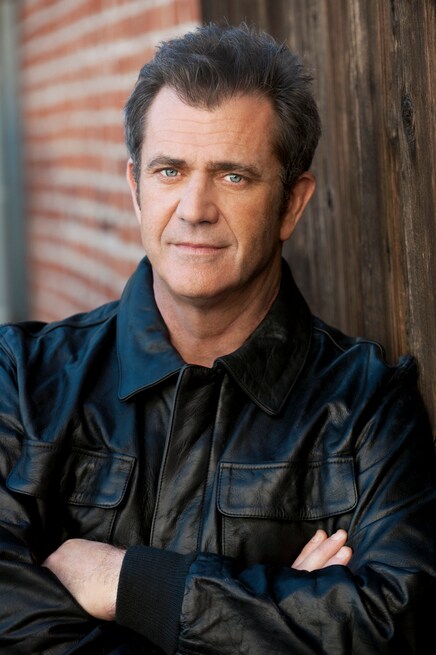THE AVIATOR, recensione




Quivi libero da restrittivi e pedanti, quasi dittatoriali dettami editoriali e tediose regole SEO ammorbanti, recensirò il controverso, fascinoso, da molti erroneamente considerato “algido”, The Aviator. Opus reputato peraltro minore, a mio avviso, invece, quasi il migliore del quintetto collaborativo fra Leo Dicaprio e monsieur Scorsese. Detto ciò, The Aviator non è affatto un capolavoro e nemmeno gli si avvicina, eppur in molti punti avvince, addirittura emoziona e commuove, in virtù d’uno stratosferico DiCaprio di natura brandiana, mimetico in modo spettacolare e carismatico oltre l’immaginabile. Sebbene, nel suo incipit e forse per la prima ora di tal pellicola dalla durata corposa, ai limiti dell’insopportabile, specialmente interminabile, la sua recitazione appaia, a prima vista, artefatta e già imitativa del De Niro dei tempi d’oro. Tutto mossette con la solita manina a lisciarsi i capelli e la nuca impomatata del suo Howard Hughes non biondo di natura, com’è Leo, bensì corvino. Pian piano, la sua recitativa prova, ripeto, inizialmente e apparentemente incerta, s’innalza ed è il caso di dirlo, si brucia come Icaro? No, prende il volo ad alta quota alla pari dell’Hercules, l’idrovolante da trasporto progettato, da tempo immemorabile, da Hughes, in questo fascinoso, seppur irrisolto, contorto e anomalo biopic rutilante ed estroso, diretto da Scorsese e sceneggiato-romanzato, molto all’acqua di rose e con punte nella retorica più tronfia, dallo specialista giustappunto dei colossal dispendiosi, alias John Logan. The Aviator ebbe un budget dalla portata clamorosa e metaforicamente analoga a un enorme transatlantico dell’aeronautica militare ma, obiettivamente, fu girato, non sol in cielo, assai meglio di Top Gun: Maverick.
Se non avete mai visto questo film, oramai uscito nei cinema mondiali ben due decadi or sono e, prima di vederlo, voleste leggerne la trama “dettagliata”, altresì inevitabilmente sommaria e generalista, ovviamente eccovi appioppato, sottostante, il link alle parole detteci e fornite noi da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/The_Aviator
Un cast bellamente assortito e ineguagliabile ove, oltre al citato super protagonista assoluto DiCaprio, svetta naturalmente Cate Blanchett, per tale suo ruolo vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista, nei panni dell’ex moglie di Hughes, ovverosia la diva ed eterna Katharine Hepburn, neanche a farlo apposta, oppure casualità non ricercata, ah, delir(i)o, a tutt’oggi l’attrice detentrice del record di Academy Awards vinti come incontestata Best Actress insuperata. Poi sposa di Spencer Tracy e donna complessa(ta), malgrado da “chiunque” amata…
Kate Beckinsale è invece un’Ava Gardner figa ma senz’aura, priva di vita, totalmente anodina e addirittura impalpabile, “bruttina”. Cosicché, fra un Alec Baldwin già grasso ma bravo, non ancora indagato e inguaiato, una fulminea toccata e fuga più rientrata in scena “muta” e pressoché invisibile, nella scena all’ospedale in cui Hughes è ricoverato e gravemente traumatizzato, d’un Jude Law/Errol Flynn fisionomicamente discutibile, Ian Holm, un cammeo di Willem Dafoe piuttosto insignificante, un eccellente John C. Reilly, un magnifico, serpentesco Alan Alda e un perfetto Danny Huston impeccabile, Gewn Stefani è un’impresentabile Jean Harlow che pronuncia tre battute in croce e pare perennemente imbarazzata a incarnarne la parte e basta? No, a recitare, per di più in un film non magistrale ma diretto, checché se ne dica, da un maestro incontestabile. Fotografia visionaria d’un ispirato Robert Richardson, ex aficionado, diciamo, a livello puramente lavorativo, di Oliver Stone e di Scorsese stesso, ora di Tarantino, compresi i film girati da quest’ultimo con DiCaprio, vale a dire Django Unchained e C’era una volta a… Hollywood, per un’opera maestosa, per l’appunto, sul piano visivo e per DiCaprio & la Blanchett + Huston sul versante interpretativo, ma non sempre convincente su quello narrativo. The Aviator è un bel film, troppo lungo, demodé o sol d’uno Scorsese, già vent’anni fa, cinematograficamente âgée e vagamente rincoglionito, rimasto fermo alla grandeur “arty”, sovente superflua e perfino irritante, di New York New York? È una domanda? Sì. È fissato con Frank Sinatra e lo menziona quasi sempre, doveva girarne un film biografico proprio con DiCaprio, dapprima diverso, altresì mai visto e non concretizzatosi, intitolato però Dino, più incentrato sul “compagno” epocale di The Voice/occhi blu, cioè Dean Martin.
Meglio così, sarebbe stata una stronzata qual è, ahinoi, oggettivamente, scevri d’ogni futile reverenza autoriale stupida e quindi immotivata, Killers of the Flower Moon. Con buona pace molti suoi ammiratori (inde)fessi e sfrenati, financo di me stesso che tendo a voler testardamente credere che sia un capolavoro perché non voglio riconoscere la verità ineluttabile, la seguente… Martin, ti abbiamo venerato ma è tempo, se non di morire, di lasciar perdere con la settima arte, vedi di crescere le tue figlie e so che hai lavorato con Leo perché speravi che una di esse, conoscendolo sul set e altrove, potesse scoparlo e scoparlo. Per quanto Leo ti voglia bene, le tue figlie so’ indubbiamente racchie senza fine e i tuoi film, oggi come oggi, so’ più vecchi, in ogni senso di te. Quando morirai, zio Marty, il sottoscritto, girando un lungometraggio a commemorazione della tua tristissima dipartita e a mo’ della trasmissione radiofonica del finale di Killers of the Flower Moon, ti promette che non ne sarà solamente regista, bensì interpreterà la particina nientepopodimeno di te (re)incarnato nel tuo film sopra dettovi, pronunciando le lapidarie parole… È una tragedia? Forse no. Mollie/Lily Gladstone, no, scusate, nessuna delle figlie di Martin(o) giammai sposò e sposerà Ernest Burkhart, no, DiCaprio. Si salveranno e si salvarono da un puttaniere che, su cinque film (al momento, cazzo) da te diretti, assomigliò a Marlon Brando sol in The Aviator. Stendiamo invece un velo pietoso sulla sua penosa imitazione “parodica” di Killers…
Nei titoli di coda del mio film, un attore mi domanderà:
– Non ti piace DiCaprio?
– Mi piacque in Titanic e in “tal” The Aviator ma se ti dico, onestamente, che generalmente mi fa schifo al cazzo, mi togli l’amicizia su Facebook? Anzi, ti blocco subito, così non mi spii. Inoltre, guarda che io e te non dobbiamo mica sposarci e non ho intenzione di sposare Leo anche perché non è sposato e mai lo sarà. Quindi salutami (a) Scorsese, sor(r)eta e Leo. Stamm’ buon’, tante belle cose alla tua famiglia di Goodfellas.
– Ehi, che modi sono? T’insegno un po’ di rispetto.
– Sai che fine fa il personaggio di Frank Vincent in Quei bravi ragazzi?
– No.
– Presto lo saprai. E non sarà un film in cui, per finzione, ne interpreterai il “character”.




Cala il sipario, compare Scorsese rinato, no, la scritta The End e appaiono i titoli di coda. Al che, nel bel mezzo di essi, spunta una faccia da culo, la mia, che esclama:
– Francamente, spettatori, il mio film vi ha provocato ribrezzo, lo so, non ne avete capito lo spirito dissacrante ma, detta fra noi, siete gli stessi che pagaste il biglietto (e non solo) per Killers of the Flower Moon, dunque nessun rimborso! Tornate a casa e fottete(vi)!
Sì, idioti, finitela col Cinema! Roba che poteva andar benino ai tempi di Angeli dell’inferno!
Illusi, sfigati, minus habentes, insomma, poveri cristi, sveglia!!!
Ma vi rendete conto? State a guardare le vite degli altri, per di più persino finte e spesso rese buoniste per non incorrere nella censura e nell’emarginazione di chi, moralista, urlerebbe:
– Non fate più lavorare quel porco! Deve “crepare”, per colpa del maccartismo, come De Niro di Indiziato di reato. Che non ha la fotografia di Richardson ma dell’ex habitué di Scorsese, Michael Balhaus, con una comparsata di Scorsese stesso. Nel pre-finale di The Aviator, nella scena in aula giudiziaria, gli echi di Guilty by Suspicion ci sono tutti, in maniera figurata, no, figurativa e cromatica. Nevvero?

di Stefano Falotico
NOSTALGIA, recensione


Libero da vincoli editoriali e da asfissianti regole pedanti, ancor influenzato, altresì tanto raffreddato quanto ironico e scevro da ogni virus intestinale, no, ammaliante, no, sol ammalante influencer ammorbante e solamente appariscente-deficiente, quest’ultimo bravo, per modo di dire, sol ad essere lui stesso febbricitante di maieutica a buon mercato rionale o da Rione Sanità, ivi recensirò Nostalgia. Da me visionato ieri, in data primo gennaio di tal 2024, anno appena iniziato che si spera meno cagionevole, non solo di salute, bensì anche in senso metaforico, di quello appeno trascorso. Attenendoci, ivi utilizzando il plurale maiestatico, alle prime righe della trama riportataci da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Nostalgia_(film_2022)
Dopo quarant’anni vissuti tra il Libano, il Sudafrica e l’Egitto, Felice Lasco torna nel luogo dov’è nato, il rione Sanità di Napoli, richiamato da un oscuro passato. Qui ritrova la madre ormai anziana e cieca, di cui si prende cura nelle ultime fasi della sua vita. Dopo la morte della donna, Felice confida a Raffaele, un vecchio fornitore di pelli e spasimante della madre, che da adolescente aveva un caro amico, Oreste Spasiano, che negli ultimi giorni gli ha fatto bruciare la motocicletta e intimare di andarsene. Raffaele gli rivela che Oreste, noto come ‘o’ Mal’omm, è il più pericoloso boss camorrista della Sanità, e lo invita paternamente a tornare in Egitto, dove è rimasta la moglie.
Martone, partenopeo di origine controllata, quando ambienterà un suo film, che ne so, a Bologna, mia città natia, malgrado non mi piaccia e non possegga origini felsinee? Mai. È chiaro. Così come è chiaro che, dopo una fase creativa altalenante, Martone sta cominciando a girare pellicole a tutt’andare in quanto non vuole estinguersi come il Vesuvio, bensì essere vesuviano, no, vulcanico ed eruttivo in fase “ultimi fuochi” da San Silvestro? Quante cartucce ha ancora da sparare prima di spararsi alla pari d’un gangster inchiappettato e all’ergastolo condannato a Poggioreale? No, ah ah, scherzo. Martone sa come usare i peti, no, petardi cinematografici e i suoi film sono botti di Capodanno, no, botte allo stomaco in competizione con Paolo Sorrentino, ovviamente, altro napoletano verace e amante delle vongole non solo veraci. Martone conobbe Toni Servillo, naturalmente amico e compagno fidato di Totò, no, Sorrentino, e vi lavorò per Qui rido io. È tutto un magna magna, parafrasando il Bettino Craxi di Pierfrancesco Favino in Hammamet by Gianni Amelio. Martone sa, alla stessa maniera di Filippo Scotti/Fabietto Schisa di È stata la mano di dio, che da Napoli nessune fugge veramente mai. Napoli t’imprigiona non solo in una cultura e mentalità oramai, per sempre, aderenti al substrato inconscio in te formatosi, bensì, anche quando te ne vai per molto tempo come Favino/Felice Lasco, senza di “lei” diventi infelice poiché la patria di Pulcinella t’incarcera nella sausade. Sì, quell’analogo sentimento brasiliano, agrodolce e melanconico di nostalgica voglia di ritornare e sprofondare, in ogni senso, nelle viscere delle tue irrinunciabili origini. Sceneggiato dallo stesso Martone ed Ippolita Di Majo a partire dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea, Nostalgia è l’ennesimo film su Napoli, giustappunto, d’un regista che, anche quando girò il suo biopic su Giacomo Leopardi, nato a Recanati, intitolato Il giovane favoloso con Elio Germano, doveva andare a parare su Luisa Ranieri, no, Massimo Ranieri, no, Antonio Ranieri, celeberrimo amante dell’autore de L’infinito… Per dirla à la Peppino De Filippo, campeggiante ivi in uno storico graffito, e ho detto tutto…
Nostalgia è un bel film, non un capolavoro ma non aveva, onestamente, nessuna possibilità di entrare nella cinquina dei film candidati all’Oscar come Best Foreign Language. Perché Martone non è paraculo come Sorrentino, la sua Napoli non è ruffiana e quasi mai da cartolina malgrado le soffici e fascinose luci del direttore della fotografia Paolo Camera. Cinematographer, peraltro, di quell’Io capitano di Mario Martone, no, Matteo Garrone, che è invece, a dircela francamente, un romanaccio volpone! Ché, dopo la nomination ai Golden Globes, potrebbe perfino spuntarla agli Oscar… chiamalo coglione… Favino se la cava egregiamente ma la vera sorpresa è Tommaso Ragno. Appena poco prima, lo vedemmo ingrassato in Tre piani, mentre qua il vero De Niro italiano è lui, altro che Servillo. Per incarnare O’ Malommo adottò lo stesso metodo “Max Cady”… È eccelso e fa ribrezzo il suo character, al contempo è affascinante da morire, è l’uomo di merda che nessuno, tutti vorrebbero essere.
di Stefano Falotico
WONKA, recensione
Oggi recensiamo l’attesissimo e già acclamato dall’intellighenzia critica internazionale, Wonka, firmato dal regista di Paddington, ovverosia Paul King, ivi anche sceneggiatore assieme a Simon Farnaby (Rogue One).
King & Farnaby, per questo prequel del celeberrimo romanzo di Roald Dahl, (La meravigliosa storia di Henry Sugar) La fabbrica di cioccolato, già portato sul schermo da Mel Stuart con l’omonima trasposizione famosa con Gene Wilder, nel ‘71, e nel 2005 da Tim Burton per la sua controversa versione con Johnny Depp (Donnie Brasco), hanno, di purissima e lodevole fantasia proficua, inventato una storia del tutto originale, profondamente innovativa e ripiena di strabilianti invenzioni scenografico-visive abbacinanti per lo sguardo, donando nuova e scoppiettante linfa vitale all’opera originaria del suddetto Dahl e conferendogli altresì una brillante connotazione personale, a nostro avviso, stimolante e degna di nota. Trovando, per l’occasione, nell’eccellente e al solito magnetico Timothée Chalamet (Bones & All, Dune), peraltro, candidato giustamente al Golden Globe nella categoria di miglior attore comedy/musical, l’interprete ideale a incarnare, giustappunto, gli eccentrici panni del protagonista che dà il titolo a tale godibilissimo opus contagiosamente benefico e squisitamente allineato al lieto clima natalizio.
Pellicola della corposa eppur mai noiosa, avvincente e, ribadiamo, assai piacevole durata di centosedici minuti netti, Wonka, così come maggiormente più avanti esplicheremo con più sottigliezza, approfondendo in merito, brilla di luce propria e non poche volte incanta e strabilia, ipnotizzandoci alla sua visione e al contempo parecchio divertendoci con gusto e raffinatezza.
Trama, notevolmente sintetizzatavi e dunque concisa per non rovinarvene la visione e rivelarvi le belle sorprese amabili:
Il giovane e un po’ scapestrato, inesperto, analfabeta eppur ottimista e di buon cuore orfano Willy Wonka (Chalamet), il quale in tenerissima età perse la madre (Sally Hawkins) che, a sua volta, prima di lasciarlo lo incitò a un atteggiamento positivo e dolce nei riguardi della vita, dopo una lunga traversata marina, scende baldanzoso dalla nave e giunge in una città straniera per coronare il suo atavico sogno di aprire una raffinata cioccolateria nell’elegante Galeries Gourmet. Tale suo intimo desiderio vien però subito osteggiato e messo a dura prova dalla polizia locale che non lo vede di buon occhio.
Inoltre, Wonka, il quale aveva preso sistemazione “alberghiera” in un confortevole, pittoresco, sebbene un po’ sinistro, caseggiato del luogo, subisce un capzioso raggiro malevolo da parte dell’apparentemente gentile e premurosa, invero perfida proprietaria dello stabile, la signora Scrubbit (un’Olivia Colman al solito bravissima sebbene leggermente irriconoscibile in quanto fortemente truccata e “conciata per le feste”) che, giustappunto, in combutta col marito bifolco di nome Bleacher (Tom Davis), parimenti furbacchione e losco, è specializzata nel plagiare i suoi clienti. I quali, avendo firmato delle clausole pressoché invisibili a occhio nudo, prima di prendere alloggio nel suo locale, non potendo poi sostenerne le assai esose spese, son obbligati a divenirne schiavi e a lavorare duramente alle sue ferree dipendenze nel lavatoio sotterraneo. Qui, Wonka conosce però la coetanea e avvenente Noodle (Calah Lane) e se innamora perdutamente, prestamente ricambiato. Wonka, fra mille peripezie e più o meno rocambolesche disavventure adrenaliniche, entra in contatto con un curioso nano Umpa Lumpa (uno strepitoso Hugh Grant digitalmente rimpicciolito) che gli confida di averlo in passato frodato ma che, a modo proprio, è suo fan sfegatato. Ci fermiamo qui col narrarvi la vicenda, lasciandovela gustare tutta d’un fiato, in quanto è prelibata come un cioccolatino succulento e, ancor evidenziamo, non abbiamo intenzione naturalmente di sciuparvene il piacevolissimo gusto che, speriamo, vogliate assaggiare.



Soprattutto nel suo incipit, Wonka assomiglia non poco, per ambientazione e romantiche, languide atmosfere evocative, al bellissimo Hugo Cabret di Scorsese e perfino al sottovalutato Pinocchio di Robert Zemeckis. La regia di King è accorta e sensibile, in alcuni momenti, specialmente quelli cantati, sensazionale e incantevole, ben coadiuvata da una fastosa scenografia impeccabile mirabilmente curata da Nathan Crowley, frequente collaboratore di Christopher Nolan (da Insomnia sin a Tenet) e autore di lavori altrettanto importanti in pellicole come Nemico pubblico di Michael Mann e First Man di Damien Chazelle. Ma a farla da padrone assoluto della pellicola è, ribadiamo, uno Chalamet in totale stato di grazia, impressionante per forza espressiva in ogni singola inquadratura, per di più ottimamente affiancato, nel suo assolo e one man show ampiamente meritevole d’applausi scroscianti a scena aperta, da un cast egualmente superbo in cui, oltre alle già succitate presenze della Colman e di Grant, son altresì certamente da annotare gli apporti recitativi di Jim Carter, Paterson Joseph nel ruolo di Arthur Slugworth, di Matt Lucas e d’un irresistibile Rowan Atkinson (Mr. Bean) in versione prete.
Wonka ha forse soltanto un’evidente e clamorosa pecca. Ovvero, se dal punto di vista formale e prettamente musicale è indiscutibilmente fantasmagorico, cioè una perlacea meraviglia, e suggestivamente coreografato, risulta invece molto carente e alquanto banale nei dialoghi e abbastanza scarno nell’intreccio in sé, in verità, troppo semplicistico e scontato. La caratterizzazione psicologica, infine, dei cattivi è, come si suol dire, tagliata con l’accetta e quindi manichea. Però sono debolezze perdonabili anche perché Wonka, fondamentalmente, si rivolge a un pubblico principalmente formato da bambini e dunque è accettabile, datone il tono fiabesco e infantile, che non sia complicato e troppo sfaccettato a livello intrinsecamente narrativo, psicologico e dialogico. Perdonateci per il seguente gioco di parole, la sua “ingenuità” ci par funzionale e logica.
Piccola curiosità: veramente incredibile la coincidenza, chissà se fortuita, per cui sia in Wonka che in Buon Natale da Candy Lane, odierne pellicole natalizie pressoché uscite in contemporanea, entrambi i protagonisti, rispettivamente incarnati da Chalamet e Eddie Murphy, si trovano inguaiati finanziariamente per aver firmato erroneamente e “sbadatamente” delle condizioni scritte in minuscolo.

di Stefano Falotico
JERRY MAGUIRE, recensione

JERRY MAGUIRE, Kelly Preston, 1996, (c)TriStar Pictures

JERRY MAGUIRE, Renee Zellweger, 1996

JERRY MAGUIRE, Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., 1996, (c)TriStar Pictures
Libero, fortunatamente e vivamente, da vincoli editoriali e da coatte regole asfissianti il mio libero arbitrio di natura non so se solo recensoria, disamino ivi uno dei film più brutti, no, solamente godibili, no, imbevibili e indigeribili dell’intera storia del Cinema. Se di Cinema, con la “c” maiuscola (tra virgolette in minuscolo), in tal caso esemplare d’imperialismo stolto, statunitense di mainstream becero, si può parlare. Vidi quest’obbrobrioso example di propagandistico giocattolo fake di celluloide improntata al buonismo più lezioso, quando uscì nei cinema italiani, dunque circa tre decadi fa. Poiché fui trascinato a vederlo da una compagnia di liceali del Minghetti bolognese, scuola/etta per figli di papà minchioni e inetti, fetenti e strafottenti Gremlins (non) viventi, nerd irredimibili e dementi, str… etti ancor irredenti, sempre ridenti e carnascialeschi, sporchi nell’animo veramente, specialmente incurabilmente, frequentata da ragazzine pubescenti, anzi, già adolescenti putrescenti, in calore “florido”, con tanto di batterica flora intestinale assai prematura e mestruazioni più annessi assorbenti da teenager vogliose di qualcosa di libidinoso che, dopo essere andate in brodo di giuggiole con “toccamenti” vari per Patrick Swayze di Dirty Dancing, non poco in modo pulito e proibito sognavano di copulare con mr. perfettino Tom Cruise, all’epoca l’incarnazione dell’edonismo reaganiano post Top Gun e faccia da culo imbattibile, soprattutto insopportabile. Qualcosa di tremendamente micidiale, dovete credermi. Paolo Mereghetti, nel suo discutibile, peraltro, Dizionario dei Film, fu però sin troppo buono nei riguardi di tal porcume “firmato” da Cameron Crowe. Assegnandogli infatti due stellette piene, sin troppo lusinghiere. Tale filmaccio è sol un concentrato di banalità a buon mercato e luoghi comuni protesi al fanatismo del culto virile, mascherato da storia d’amore più finta di Renée Zellweger. Se voleste leggerne la trama, dettagliata e al contempo sommaria, cari somari che credete alle stronzate a stelle di Mereghetti, no, a stelle e strisce, e alle sciocchezze di Wikipedia, eccovene il link, copia-incollatovi da tale generalista enciclopedia online adatta a Qui, Quo, Qua da Manuale delle giovani mignotte, no, marmotte: https://it.wikipedia.org/wiki/Jerry_Maguire
Jerry Maguire, profluvio sterminato di scempiaggini a iosa, della durata netta e interminabile, per l’appunto, di centoquaranta minuti sfiancanti a dismisura, paradossalmente tenuta in piedi soltanto da un Tom Cruise che fa la sua porca figa, incarnata da Kelly Preston, no, figura, talmente incredibile, in senso tout–court e anche più grottesco del termine in senso figurato, giammai in volto sfigurato, no, perennemente “figo” anche nelle scene in cui, disperato, dovrebbe essere in viso sciupato e che, prima di scrivere la sua “acculturata” relazione programmatica incentrata sul cambiamento socio-professionale, si mostra semi-culturista a torso nudo impeccabilmente scolpito e addome più piatto di quello del Cuba Gooding Jr., quest’ultimo ingiustamente oscarizzato perché all’Academy fece simpatia tal ex ballerino neretto più meritevole, a lor avviso macroscopicamente erroneo in maniera mostruosa, di Ed Norton di Schegge di paura (https://it.wikipedia.org/wiki/Premi_Oscar_1997) Un’imperdonabile svista clamorosa, scandalosa in modo ignominioso davvero inglorioso. In colonna sonora, da ruffiano pre-Almost Famous, aggiungo e ho detto tutto riguardo questo miserabile leccaculo dei ragazzini più cretini di (cog)nome Crowe, una (sara)banda d’imbecilli cantanti neo-melodici falsamente trasgressivi dell’internazionale scena pop rock di quei tempi di me… rda, ovverosia l’handicappato Jerry Cantrell degli sdolcinati Alice in Chains, il quale compare addirittura di cameo oltre a donnette deficienti impresentabili e odiose in modo sesquipedale, cioè le vere ex dello stesso Tom Cruise, ma non Mimi Rogers e Rebecca De Mornay, ah ah. Produce James L. Brooks (Voglia di tenerezza, Qualcosa è cambiato), fotografa l’artefatto cinematographer per antonomasia di Steven Spielberg, alias Janusz Kaminski. Che, assieme allo stesso Spielberg & Cruise, poco dopo avrebbe diretto la fotografia di Minority Report e La guerra dei mondi, altri due film abbastanza immondi. Diciamocela! Se all’epoca il film mi fece schifo e lo considerai alla pari d’una diarrea terribile, rivedere questa pazzesca ca… ta m’indusse al voltastomaco immediato e incontenibile. Per fortuna, due pastiglie di Pursennid, famoso “stimolante” e diuretico efficace, m’aiutarono a digerirlo e smerdarlo giustamente e catarticamente.

JERRY MAGUIRE, Renee Zellweger, Tom Cruise, 1996, (c) TriStar

JERRY MAGUIRE, Cuba Gooding Jr., 1996
In conclusione: Una cagata pazzesca, marrone come Cuba!
di Stefano Falotico
NAPOLEON, recensione
Ebbene, oggi recensiamo in forma stringata, speriamo altresì esaustiva e secca, l’atteso biopic firmato da Ridley Scott (I duellanti, Blade Runner, Il genio della truffa), dedicato alla celeberrima e al contempo controversa figura monumentale di Napoleone Bonaparte, ça va sans dire, Napoleon.
Titolo originale lasciato immutato mondialmente, film della consistente e granitica, sebbene un po’ narrativamente sfilacciata, così come esplicheremo più avanti, spiegandovi perché, durata di centocinquantotto minuti netti, sovente appassionanti ma, a nostro avviso, non sempre convincenti e compiuti pienamente. Il prolifico, instancabile Scott, alla veneranda età di ottantacinque primavere, vicinissimo peraltro alla soglia degli 86 anni che compirà immantinente, ovvero il prossimo 30 novembre, par non accusare il trascorrere del tempo, bensì giovanilmente, in ottima vigoria psicofisica e, ripetiamo, invidiabile volontà immarcescibile, continua a sfornare pellicole a tutt’andare, per di più realizzando opuses ad altissimo budget e dunque ad elevato tasso impegnativo nel senso più prettamente produttivo.
Napoleon, infatti, è costato circa 200 milioni di dollari, cifra fortemente considerevole che s’evince totalmente durante la sua visione, in quanto è facilmente ravvisabile la grandeur visivo-scenografica che, in modo indubbio, deve aver richiesto uno sforzo notevole. Ciononostante, al di là del suo impianto faraonico e della sua magniloquenza abbacinante, elementi sui quali Scott è indiscusso maestro sin dai suoi esordi cineastici, se dal punto di vista formale è perciò ineccepibile, Napoleon ci è parso inerte sul piano puramente emozionale, apparendoci infatti disorganico e amorfo.
Sceneggiato nuovamente, dopo Tutti i soldi del mondo, dal suo “fido scudiero” sceneggiatore David Scarpa, autore inoltre del venturo Il gladiatore 2 a cui l’infermabile Scott, terminato lo sciopero di Hollywood che ne ha bloccato per sette mesi abbondanti le riprese, si sta già dedicando al fine di completarne gli ultimi ciak, Napoleon, in forma romanzata e personalmente inquadrata nell’ottica poetica e concettuale di Scott, ci racconta l’excursus del celebre condottiero, imperatore e stratega Bonaparte (incarnato da un sulfureo Joaquin Phoenix), partendo naturalmente dalla sua inarrestabile ascesa e arrivando alla sua auto-incoronazione storica e arcinota, proseguendo poi coi suoi esili dapprima nell’Isola d’Elba e poi a Sant’Elena, contemporaneamente narrandoci, in un flusso d’immagini sinuose e vertiginosamente pindariche, attraverso un fascinoso eppur contorto, non perfettamente omogeneo, dunque sbilanciato e sol a tratti ben orchestrato, intreccio a base di magmatico tourbillon tanto suggestivo quanto leggermente sterile sul piano psicologico, la sua passionale, altresì tormentata love story con Giuseppina (Vanessa Kirby), a sua volta intervallata e ordita da famosi episodi ritraenti le sue battaglie più notorie, in particolar modo quelle di Austerlitz e della lapidaria Waterloo.
Meraviglioso e impeccabile sul piano estetico (fotografia, al solito, dell’habitué di Scott, Dariusz Wolski) sorretto da una buona prova, forse però non del tutto eccellente, d’un Phoenix bravo ma di certo, paradossalmente, poco calzante nei panni di Bonaparte, meno efficace e carismatico rispetto a sue superiori prove in ruoli di personaggi “minori” e anonimi, a differenza invece d’una Kirby strepitosa, Napoleon incanta e strabilia per splendore, giustappunto, immaginifico, lasciando invece alquanto a desiderare sul versante, come sopra già dettovi e nelle righe seguenti presto rimarcatovi, della potenza della storia in sé, ovviamente intesa in senso lato e inerente, ovviamente e unicamente, il mood discutibile, anzi, scarsamente emozionante, con cui Scott l’ha solipsisticamente filmata e adattata, filtrata dal suo sguardo. Secondo noi, metaforicamente opaco e vetusto, tristemente senile, sostanzialmente superficiale, troppo attento ai dettagli e ai particolari della messa in scena ma, di contraltare, distratto dal renderla vivamente corposa e degna d’interesse pulsante. Poiché noi spettatori, durante le sue due ore e mezza di minutaggio roboante e maestoso fotograficamente ma povero di pathos vivido, non siamo quasi mai avvinti da ciò che ci viene mostrato oltre la sua lussuosa confezione luccicante. In quanto Scott non sa rendercene partecipi e si concentra quasi esclusivamente sulla bellezza figurativa.
Gli sprazzi di grande Cinema ci sono, eccome, parimenti non mancano gli “spruzzi” cromatici d’un Wolski ispirato e la turbinosa e torbida, infedele storia d’amore fra Napoleone e Giuseppina è sia inquietante e straziante che, in alcuni momenti, toccante. Ma, nella sua interezza, Napoleon è inconsistente, meramente estetizzante e, alla pari dell’incapacità di Giuseppina di procreare, è cinematograficamente infecondo e non vitalistico.
Un Cinema, insomma, molto bello da vedere, perfino stavolta, a differenza di altri film storici di Scott, poco sbagliato storiograficamente, a dispetto sia chiaro d’indubbie e inaccettabili licenze poetiche, ma vuoto, purtroppo, mortifero e figlio d’un regista oramai perso nella sua ipertrofica megalomania inutile e patetica.
Bellissimo visivamente, emozionalmente inesistente. Una creatura mal partorita da uno Scott più sterile della cara e stronza Joséphine. Bravino Joaquin ma questo film rimane una cagatina colossal? Eh già.
Scott, sei proprio cott(o). Ti prendo a sculacciate! Ah ah.
di Stefano Falotico